da “Il Nuovo Areopago”, anno 1 numero 1, primavera 1982, pp. 152-161
“Eschilo, figlio di Euforione, ateniese, morto a.Gela produttrice di grano, questo monumento ricopre: il bosco di Maratona potrebbe raccontare il suo glorioso valore, e il Medo dalle lunghe chiome, che lo conosce”. Questo l’epitafio posto sulla tomba di Eschilo e dettato probabilmente dal tragico stesso. Un poeta greco del nostro tempo, Costantino Kavafis, nella poesia Giovani di Sidone, si ribella contro la scelta operata dal suo antico connazionale che, dimenticando “la splendida Parola della Tragedia”, ha preferito lasciare come memoria di sé “solo il fatto che fra le schiere dei soldati anche tu combattesti contro Dati e Artaferne”. E certamente il giovane sidonio fanatico di letteratura che nei versi di Kavafis pronuncia queste parole esprime lo stupore e la perplessità di molti altri prima di lui, all’idea che Eschilo si sentisse, prima e più che poeta, cittadino ateniese e partecipe della lotta combattuta dai suoi contro i Persiani.
L’indagare come Eschilo, nella profonda coscienza di avere in quanto poeta una missione educatrice e profetica nei confronti del suo pubblico – non un pubblico disparato e anonimo, ma, secondo l’uso ateniese, la cittadinanza tutta durante le feste di Dioniso –, possa essere compiutamente e integralmente polites di Atene e nello stesso tempo andare al fondo del significato dell’uomo e comunicarlo, con la splendida “Parola della Tragedia”, all’umanità di ogni epoca, non è né nostra intenzione né nostro compito. Quello che ci proponiamo di ricercare è in che modo il poeta che combatté a Maratona abbia espresso nella sua opera la coscienza di essere greco e il giudizio nei confronti dei non-greci, dei barbari, dei diversi, dei nemici: in un’epoca, il quinto secolo, in cui il problema del rapporto politico e culturale fra Greci e barbari era particolarmente sentito, si ritrova in lirici come Pindaro (in particolare nella IV Pitica e nella X Nemea) ed è sotteso a tutta l’opera storica di Erodoto, con approdi a volte assai diversi da quelli eschilei.
È necessario seguire due linee di ricerca: la prima ci porta a sottolineare la coscienza, in Eschilo, di una diversità storica, di una distanza e di una superiorità del greco sul barbaro, nonostante la sproporzione di numero e di forza; la seconda ci fa ripercorrere una lunga e complessa vicenda primordiale che affratella nell’origine tutti i popoli che la storia ha diviso, e individua in essi le tappe di una stirpe unitaria, i momenti di un’evoluzione etnico-culturale che ha generato inimicizie e nuovi legami ed ha all’inizio e in ogni suo momento la presenza misteriosa di un dio. Purtroppo, se la prima linea ci è chiaramente nota, la seconda emerge solo a tratti, attraverso opere e frammenti superstiti: con prudenza ci varremo di altre testimonianze per illuminarne i tratti perduti nel naufragio di molte tragedie.
I
La tragedia in cui soprattutto si trovano a confronto Greci e barbari è naturalmente i Persiani, rappresentata pochi anni dopo la vittoria greca sull’esercito invasore di Serse. Opera di particolare interesse per più di un motivo: è la più antica tragedia pervenutaci (secondo la cronologia oggi più accreditata); è l’unica di argomento non mitologico ma storico, per di più di storia molto recente; presenta infine un ribaltamento di prospettiva, poiché la scena è posta nella capitale persiana, e il tema non è la vittoria greca bensì la sconfitta dei barbari: la regina madre e gli anziani attendono con ansia e timore, vanamente cercando di rincuorarsi a vicenda, che giungano notizie della spedizione; l’arrivo di un messaggero, l’apparizione dell’ombra del precedente re Dario e infine il sopraggiungere del sovrano sconfitto e disperato privano i rimasti in patria di ogni speranza e illusione: “completamente distrutta è la potenza persiana” (v. 714). Opera anche di difficile lettura, che a fatica si potrebbe definire storica, perché i fatti dei precedenti anni o decenni sono riportati, taciuti o falsati liberamente e figure come quella di Dario hanno perso i loro reali connotati; storia e metastoria s’intrecciano continuamente, giudizio politico ed etico-religioso coesistono, la celebrazione d’Atene si mescola alla pietà per i vinti e a un più profondo discorso sull’uomo. È con attenzione perciò che va individuato l’aspetto più storicamente contingente dell’opera, vale a dire il raffronto fra i due popoli in lotta: altrimenti si rischia, come alcuni critici, di vedere nella colpa di Serse, che ha violato le leggi della natura e la volontà degli dèi, non un suo personale peccato, ma un difetto nazionale: dimenticando che non diversa è la colpa attribuita a un dio come Prometeo o a un greco come Agamennone, e che l’autore stesso libera da ogni responsabilità analoga (storicamente accertata, fra l’altro) sia Dario sia i predecessori, fino agli inizi della stirpe.
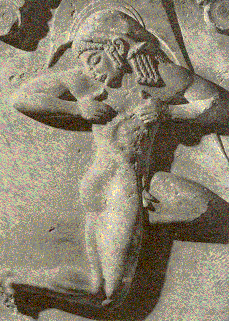
(Atene, Museo Nazionale)
Raffronto fra due popoli in lotta, si diceva: ma il punto fondamentale, la differenza più evidente sta proprio qui: i Greci sono un popolo, mentre l’impero persiano è costituito da un’accozzaglia confusa di genti diverse e casuale. Quando all’inizio della tragedia il Coro di anziani elenca la consistenza dell’esercito persiano, il sentimento prevalente in loro, accanto alla nostalgia e al timore, è il senso di potenza e quindi di fiducia che milizie così varie e numerose ispirano: ma colpisce subito il lettore, e a maggior ragione il pubblico ateniese, l’eterogencità dell’elenco: prima i Persiani, i dominatori: “partirono lasciando le mura di Susa o di Ecbatana, o dell’antica città dei Cissi … “; poi gli Egiziani: “altri inviò il grande Nilo, che molti nutre… “; gli Anatolici: “segue la folla dei Lidi delicati, che dominano tutti i popoli continentali… “; i Mesopotamici: “la ricca Babilonia invia una folla di popoli diversi in lunghe schiere… “; e infine una truppa anonima: “segue la gente armata di spada raccolta da tutta l’Asia” (vv. 16 e segg.). E questa accozzaglia di genti diverse è dominata da un solo signore, che “se vince è un uomo mirabile, se perde non deve rendere conto alla città, e, purché si salvi, è ugualmente sovrano di questa terra” (vv. 212-4). La responsabilità di Serse, assoluta in sede etico-religiosa, non è esigita in sede politica: il re non è hypeúthynos, non è cioè soggetto alle euthýnai, il rendiconto cui erano tenuti i magistrati ateniesi. Tutto l’esercito procede “sotto gli ordini gravi del re” (v. 58), e i capi dei vari contingenti sono “re sudditi del gran re” (v. 19-20).
Di fronte ad essi stanno gli ateniesi, pochi di numero, ma con la forza di un vero popolo: “Quale pastore ha il potere assoluto sull’esercito?” chiede la regina al Coro; e alla risposta “Di nessun uomo son detti schiavi né sudditi”, la regina si stupisce che possano pensare di resistere all’invasione, in una situazione che le pare di assoluta anarchia; eppure già a Maratona, dieci anni prima, “l’esercito grande e bello di Dario” era stato distrutto da quello stesso popolo senza sovrano (vv. 241-5).
Il momento culminante del contrasto fra due concezioni e realtà politiche è l’inizio della battaglia di Salamina. dopo un lungo agguato notturno, in attesa di un cenno di fuga da parte greca, gli asiatici s’accorgono che ben altra è l’intenzione dei nemici: e la descrizione eschilea sottolinea l’unità (anche linguistica), la fiducia, la baldanza di chi combatte per la patria comune, che si manifestano nella gioiosa bellezza di un canto unitario, contrapposto al confuso strepito dei barbari (1). È come se tutto fosse già implicito in tale premessa: la disastrosa conduzione della battaglia, l’agguato nell’isola di Psittalia che si ritorce rovinosamente contro i Persiani, la tragica ritirata che decima i superstiti: tutto questo è all’insegna di una caotica gestione che ben contraddice l’idea preconcetta espressa dalla regina nei versi citati più sopra. Solo la libertà, la certezza di lottare per sé stessi e per qualcosa che ci appartiene e ci è caro e sacro, dà la capacità di operare in un autentico ordine costruttivo ed efficace.
Eppure il Coro, se arriva faticosamente a comprendere il senso ultimo di quanto è accaduto, vale a dire la colpa di Serse che ha voluto violare i limiti concessi dagli dèi, non comprende invece fino alla fine il significato politico-ideale della vicenda: Eschilo lascia gli anziani di Persia legati alla loro condizione di dominatori-dominati, di sudditi orgogliosi di un re che regna su tutta l’Asia; e l’atteggiamento che prevale alla fine della tragedia è il rimpianto per i tempi in cui il potere era forte, saldo e in espansione (2).
Il tema della libertà greca contrapposta alla tirannia barbara ricorre anche in altre tragedie, e particolarmente nelle Supplici. Il Coro delle Danaidi, greche d’origine ma nate e vissute in Egitto, insiste presso il re argivo Pelasgo perché prometta di accoglierle ed aiutarle; e non riesce a percepire perché egli rifiuti d’impegnarsi prima d’aver consultato i cittadini: “Ma tu che sei la città, tu che rappresenti il popolo, capo che, non soggetto a giudizio, sei signore dell’altare, focolare della regione, con la tua volontà che decide da sola. Sul trono che ha un solo scettro tu stabilisci tutto quanto è necessario” (vv. 370-5). Ma il re è incerto, e neppure la reverenza verso supplici rifugiate presso gli altari gli impedisce di ricordare che non ha potere assoluto, pur avendo un regno che comprende quasi tutta la Grecia. E infatti sarà l’assemblea del popolo a decidere all’unanimità di soccorrere le Danaidi, approvando una mozione dalla terminologia decisamente ateniese.
Ricordiamo anche un passo dell’Agamennone, in cui il vincitore di Troia, tornato in patria, viene invitato dalla moglie a entrare nella reggia su tappeti di porpora; ma egli la rimprovera: “Non trattarmi mollemente secondo modi femminei, e non aprire la bocca dinanzi a me come una persona barbara per un grido che s’inchina al suolo, e non rendere oggetto d’invidia il mio cammino ricoprendolo con tappeti … “. Clitemestra gli obietta: “Ma che pensi di Priamo, se egli avesse ottenuto questa vittoria?” “Penso che certo avrebbe camminato su tappeti variopinti”, risponde Agamennone (vv. 918 e segg.), ribadendo il giudizio di eccesso nell’uso del potere tipico dei barbari: e certo, se nei Persiani la colpa di Serse è vista come personale, questo passo sembra suggerire che l’abitudine al potere, a ricevere inchini come divinità, può spingere alla hybris, la colpa di chi si considera più che uomo.
In quest’ultimo passo l’idea di tirannia si connette con un altro aspetto che differenzia fortemente i Greci dai barbari: questi ultimi vivono nel lusso e nella mollezza, sono delicati ed effeminati. In realtà, se in qualche punto, come il brano citato, il giudizio di valore è preciso, nei molti luoghi, soprattutto dei Persiani, in cui ricorre il tema della ricchezza o della delicatezza asiatica si ha l’impressione di trovarsi di fronte ad un topos, ad un tratto distintivo sovente senza particolare significato se non quello di ribadire una differenza e un distacco: analogamente nei Persiani si insiste sulla diversità degli strumenti di guerra fra i due eserciti: “Una guerra d’arcieri contro soldati abili con la lancia” (vv. 85-6) (3) o nelle Supplici si distinguono Greci ed Egiziani sottolineando la differenza delle fogge d’abito e dell’aspetto in genere, della vegetazione, delle bevande usuali e infine degli dèi: “Da dove viene questo stuolo a cui ci rivolgiamo? Indossa vesti non elleniche, pavoneggiandosi in pepli e veli barbari: infatti questo non è l’abbigliamento delle donne argive, né segue la foggia greca” (vv. 234-7) (4).
Così Eschilo continuamente afferma, valendosi di precise notazioni politico-ideali come di singoli fatti etnici e di costume, la differenza fra Greci e non Greci.
II
Nella tragedia Prometeo legato siamo portati ai primordi della storia universale, all’epoca della lotta fra due generazioni divine, quella dei Titani e quella più giovane degli dèi olimpici: la lotta, da poco terminata, ha dato il potere a questi ultimi, e il potere supremo a Zeus. In questo contesto di tensione cosmica vivono i loro primi passi le stirpi degli uomini, che Zeus vorrebbe far perire, ma che Prometeo, uno dei Titani superstiti, aiuta fornendo loro il fuoco e ogni elemento di vita civile e di progresso, e che per questo atto di autonomia viene punito dal nuovo re degli dèi. La tragedia ha già in sé un notevole interesse storico, poiché la lotta fra le due generazioni divine, poi riconciliate e fuse in una comune devozione da parte degli uomini, è la trasposizione mitica della lotta fra stirpi preindoeuropee e invasori indoeuropei in Europa e in Grecia in particolare; la stessa tematica ricorre nell’ultima tragedia eschilea, le Eumenidi, anch’essa giocata fra divinità vecchie e nuove, e in cui la sorte del protagonista umano, Oreste, dipende dal risolversi della tensione fra gli dèi. Ma quello che ci interessa particolarmente, ora, è un lungo episodio del Prometeo, il cui legame col resto della tragedia è piuttosto esile: l’episodio di Io.

(San Pietroburgo, Hermitage)
Io è l’unico essere umano della tragedia, ma suo padre, Inaco, è un fiume: figlio di Oceano e fratello delle Oceanidi, egli è insieme dio-fiume e uomo-re, e la sua sede è l’Argolide. A causa dell’amore di Zeus, Io è perseguitata da Era: trasformata in donna-giovenca, guardata a vista da un mostro poi ucciso da Ermes, Io è ora continuamente pungolata da un tafano, che assume a volte l’aspetto pauroso del suo guardiano defunto, e costretta, in preda a follia, a un lungo peregrinare. L’incontro con Prometeo avviene nel corso del suo vagabondaggio, e il Titano le predice le tappe future, che la porteranno, attraverso l’Europa e l’Asia, fino in Egitto, dove Zeus la quieterà e la renderà madre.
Qual è l’interesse del passo, all’interno del nostro discorso? È il fatto che questa fanciulla-giovenca, legata per parte di padre alla stirpe dei Titani ma madre di un figlio di Zeus, donna mortale in una tragedia di immortali, collocata cronologicamente ai primordi del mondo ma ambientata nettamente in Grecia, è la capostipite della più complessa stirpe mitica che l’antichità greco-romana conosca, una stirpe continuamente tesa ad attraversare il mare e a dividersi fra Europa ed Asia (di cui è parte l’Egitto, secondo la concezione antica).
Riprendiamo la parte finale delta profezia di Prometeo ad Io: “In ricordo della sua nascita da Zeus prenderà nome il nero Epafo partorito da te, che godrà dei frutti di tutta la terra irrigata dall’ampia corrente del Nilo. La quinta generazione dopo di lui, di cinquanta figlie, contro voglia ritornerà ad Argo fuggendo il matrimonio consanguineo coi cugini: questi allora, sconvolti nel senno, sparvieri che seguono non da lungi le colombe, verranno alla caccia di nozze rifiutate, ma un dio sottrarrà loro quei corpi: la terra pelasgica li accoglierà, domati da Ares che ucciderà con mano femminea, nell’audacia che veglia la notte: ogni donna infatti priverà della vita ogni uomo immergendogli in gola un pugnale a doppio taglio: così venga Cipride per i miei nemici. Ma il desiderio amoroso affascinerà una delle ragazze, sì da non uccidere il suo compagno di letto, smussando il suo proposito: fra due mali uno sceglierà: aver fama d’imbelle piuttosto che contaminarsi con un delitto: e questa partorirà in Argo una stirpe regale. Ci vorrebbe un lungo discorso per passarla in rassegna esaurientemente. Almeno dirò che da tal seme nascerà un valoroso celebre per il suo arco, che mi libererà da queste sofferenze” (vv. 850 segg.). Tre momenti della stirpe sono ricordati in questi versi:
1. il figlio di Zeus ed Io, Epafo, signore dell’Egitto;
2. la quinta generazione, che ritorna dall’Egitto alla Grecia: si tratta delle cinquanta figlie di Danao e dei cinquanta figli di Egitto, cugini fra loro, poiché Danao ed Egitto sono fratelli; come profetizza Prometco, le Danaidi fuggono ad Argo, governata allora da Pelasgo, per evitare le nozze con gli Egizi; costrette al matrimonio, s’accordano per uccidere i mariti; ma Ipermestra, innamorata dello sposo Linceo, lo risparmia e dà così séguito alla stirpe, ormai ristabilitasi in Grecia;
3. la tredicesima generazione di cui farà parte Eracle, figlio di Alcmena e di Zeus: ed è interessante che a questa stirpe appartenga l’eroe cosmopolita, le cui vicende lo portano in paesi lontani e ignoti. Sarà proprio Eracle a liberare Prometeo dalia sua punizione, col consenso del padre Zeus. Nel colloquio fra Pelasgo e le discendenti di Io fuggite dal paese del Nilo è ripreso nella tragedia le Supplici, a comprovare l’antica origine delle ragazze, il mito della progenitrice e delta sua stirpe (vv. 291 e segg.): da Epafo nacque Libia (il nome con cui i Greci designavano l’Africa), da Libia Belo, padre di Danao e di Egitto. Compaiono dunque altri due nomi, uno dei quali, Belo, è dagli studiosi assimilato a Baal, divinità semitica e particolarmente fenicia. S’insinua dunque un legame delta stirpe con la cultura semitica, e non solo con quella egizia. Ma su questo punto dovremo ritornare. Piuttosto ci interessa qui ricordare, benché i frammenti posseduti siano scarsi e in sé poco significativi, il dramma satiresco l’Amimone. Il mito ci è noto da altre fonti (Igino, fab. 14): una delle Danaidi, appunto Amimone, sfuggiva alla sorte delle sorelle, e incorreva in un’avventura assai differente: inseguita da un satiro, veniva salvata da Posidone, che si univa a lei; dall’unione fra la Danaide e il dio del mare nasceva uno dei personaggi mitici dotati, a nostro parere, di maggior fascino, forse proprio per l’ambigua oscurità che lo circonda: Nauplio. Eponimo di Nauplia, porto dell’Argolide, Nauplio è per tutta la sua esistenza legato al mare, del cui dio è figlio: marinaio e pirata, si procura la sposa, che secondo la versione dei tragici è la cretese Climene, violando le disposizioni del padre di lei, che gliel’aveva consegnata perché l’annegasse. E sul mare si consuma anche la sua più tragica impresa, la vendetta contro i Greci rei di aver ucciso il suo figlio innocente, Palamede. Anche a Palamede Eschilo dedicò una tragedia, di cui abbiamo pochi frammenti e forse, dal tenore di uno di questi (fr. 181 Radt), Nauplio doveva comparire nella tragedia, rinfacciando ai capi dell’esercito accampato sotto Troia l’assassinio del figlio, con un episodio che doveva preludere alla vendetta che altre fonti ci hanno tramandato. Palamede è greco fra i greci, eppure le sue caratteristiche di eroe culturale, di cui sono rimaste tracce anche negli esigui frammenti eschilei, lo rendono anomalo, diverso: più che il guerriero, è l’inventore, lo scopritore, il regolatore della vita umana: “Inoltre regolai la vita di tutta quanta l’Ellade e degli alleati, essa era prima confusa e simile a quella delle bestie: e per prima cosa scopersi il numero, eccellente fra le invenzioni” (fr. 470 n. 2 Radt).
Padre e figlio sono dunque personaggi di particolare importanza all’interno della stirpe: figlio di una Danaide e del dio del mare (segno di un legame ulteriore con terre ultramarine), uomo di mare egli stesso l’uno; legato alla stirpe d’Io e ad una stirpe cretese, eroe culturale e per ciò stesso “diverso”, tanto da essere eliminato dai Greci suoi beneficati l’altro. Sono molti gli studiosi (il primo fu E. Curtius nel secolo XIX) ad aver identificato in lui l’eredità culturale non greca, soprattutto fenicia, più o meno consapevolmente avvertita dall’animo greco come un fardello di dipendenza da respingere: salvo poi ad identificarla come propria e ad esaltare Palamede come il sommo per saggezza: “avete ucciso, avete ucciso, o Danai (e forse non casuale qui è il chiamare i Greci dal nome dell’antico antenato dell’eroe), il tutto-saggio, l’irreprensibile usignolo delle Muse” dirà Euripide (Palamede, fr. 588 N2).
Nello spazio di generazioni che separa il mito delle Danaidi da quello di Eracle si colloca un’altra vicenda; quella di Danae e Perseo, anch’essa legata al mare: Eschilo vi dedicò un dramma satiresco giunto in frammenti, i Pescatori con la rete. Danae è stata resa incinta da Zeus, disceso in pioggia d’oro nella prigione in cui suo padre Acrisio l’aveva celata perché non potesse generare; e Acrisio ha chiuso figlia e nipote in una cassa e l’ha gettata in mare. Il dramma satiresco rappresentava il ritrovamento della cassa e le successive vicende di Danae presso il re Polidette. Non è qui il luogo di esporre le molteplici avventure e peregrinazioni di Perseo, figlio di Danae e di Zeus: rna è importante ricordare come da Perseo i Persiani affermavano di provenire, legandosi quindi anch’essi ai molteplici nodi della discendenza di Io. Per restare ad Eschilo, notiamo che nei Persiani il ricorrere del tema dell’oro come caratteristica nazionale non è certo casuale, e infatti ai vv. 79-80 Serse è definito “di stirpe figlia dell’oro”, con un nettissimo riferimento alla nascita miracolosa di Perseo. E del resto, nel sogno raccontato da Atossa (vv. 181 e segg.), le due donne aggiogate da Serse, “l’una in pepli persiani, l’altra in abiti dorici”, sono dette sorelle della stessa stirpe. Anche il cuore delle terre barbare quindi, la Persia, ha un legame d’origine con la Grecia.

( Bilbao, Museo delle Belle Arti)
Resta da accennare, ché troppo lungo sarebbe l’approfondirlo, ad un altro ramo delta genealogia di Io, che si separa da quello in parte da noi seguito all’altezza di Belo. Un fratello di costui, Agenore, dà luogo ad una prole che si stabilisce in Fenicia e di cui fanno parte, fra l’altro, Cadmo ed Europa. La donna, rapita da Zeus che ha preso le sembianze di un toro, è da lui resa tre volte madre: “Io cominciai con un figlio grandissimo, generando Minosse… Radamanto è immortale fra i miei figli… Il terzo figlio, per il quale la mente è angosciata al pensiero, è Sarpedonte” (Europa o i Carii, fr. 99 Radt). Dunque si colloca nella stirpe anche la civiltà minoica, oltre a quella fenicia; e d’altra parte il ratto di Europa provoca un nuovo ritorno verso la Grecia, poiché Cadmo, sulle tracce della sorella, giunge in Beozia, dove fonda Tebe e dà inizio ad una complessa genealogia di cui fanno parte Dioniso (un altro figlio di Zeus) ed Edipo: il dio dell’ebbrezza e della superiore conoscenza misterica da una parte, l’uomo dalla superiore intelligenza umana dall’altra, e il loro avo comune, il fenicio Cadmo, è ricordato come scopritore ed inventore. Ma su questo ramo della stirpe le reliquie eschilee sono purtroppo assai scarse.
Se cerchiamo ora, al di là di tentativi di verifica storica o linguistica o antropologica, di trarre una conclusione dalla vicenda che abbiamo analizzato, in cui si fondono semiti e camiti, mediterranci e indeuropei, ci accorgiamo di trovarci di fronte ad un’ambiguità da cui è difficile uscire. Voleva Eschilo, come alcuni critici pensano, sostenere che la cultura dell’oriente e dell’occidente è d’origine esclusivamente greca, che i Greci sono colonizzatori e civilizzatori di tutto il mondo conosciuto, e in particolare di quelle terre oltremarine con cui erano stati in conflitto, e di nulla debitori agli altri poiché gli unici tratti esclusivamente stranieri sono negativi o comunque culturalmente indifferenti? Forse questa tendenza nazionalistica, che ben si lega col primo punto da noi trattato, era presente al poeta; ma ciò non toglie che l’idea di un’unità originaria, di una confusa parentela etnico-culturale arricchita da nuovi apporti e scambi e percorsa dalla continua azione divina, il cui inizio è posto sì in Grecia, ma in un tempo non-tempo, percorra tutta l’opera e riveli “sorelle della stessa stirpe”, pur se una subisce e l’altra rifiuta il giogo, le due donne che sono l’Asia e l’Europa.
Note
(nota 1)
“Quando il giorno con i suoi chiari puledri coprì la terra della sua bella luce, allora echeggiò dalia parte dei Greci un grido di buon augurio, a guisa di canto, e alto lo ripeté l’eco della rupe isolana; tutti i barbari, delusi nella loro speranza, furono presi da terrore: non infatti come in fuga cantavano allora i Greci un solenne peana, ma slanciandosi in battaglia con intrepido coraggio. La tromba con il suo squillo tutto là infiammava. Subito col battito concorde dei remi frementi percossero il mare profondo seguendo la cadenza, e presto furono tutti in vista: precedeva l’ala destra disposta in bell’ordine, poi seguiva tutta la flotta, e insieme si poteva udire un forte irido: “O figli dei Greci, andate, liberate la patria, liberate i figli, le spose e le sedi degli dèi patrii, e i sepolcri degli antenati: su tutto oggi si combatte”. E allora dalia nostra parte rispose uno strepito in lingua persiana…” (Persiani, vv. 386-407).
(Torna al documento principale)
“Ahimè, una vita civile davvero grande e buona abbiamo avuto in sorte, quando il vecchio re Dario pari a un dio, onnipotente, immune dal male, invincibile, comandava il paese… E quante città conquistò senza attraversare il corso dell’Alys né muoversi da focolare, come le città marittime del golfo Strimonio, vicine alle dimore dei Traci! E le città lontane dal mare che nel continente sono circondate da una cerchia di mura obbedivano a questo signore, e quelle che si vantavano di sorgere intorno all’ampio passaggio di Elle, e la Propontide ricca di golfi e la bocca del Ponto; e le isole disposte lungo il declivio marino, cinte dall’acqua, nei pressi di questa terra… E le prospere città appartenenti agli Ioni, popolose di Greci, governava con la propria saggezza, e possedeva un’instancabile forza d’uomini e di alleati d’ogni paese”. (Persiani,vv. 852 e ss.). Questo lungo passo, che nella parte omessa elenca minutamente isole e città, fa come da pendant al brano iniziale: speranza nel numero allora, nostalgia di potenza ora: e gli anziani sudditi del gran re, che pure accolgono con rimproveri Serse (ma è il compito affidato loro da Dario quello di essere d’ora in poi consiglieri del giovane re) escono di scena facendo eco ai suoi lamenti secondo gli ordini impartiti da lui.
(Torna al documento principale)
“Sono gli arcieri a vincere o la forza delta lancia appuntita ha la meglio?” (vv. 146-148). “E la punta scoccata dall’arco si vede nelle loro mani? – No: armi da duello e corazze e scudi.” (vv. 239-240).
(Torna al documento principale)
“Il frutto del papiro non supera la spiga” (vv. 761); “Troverete maschi abitanti di questa terra (d’Argo) che non bevono bevande d’orzo” (vv. 952-953); “Io rispetto le divinità del pacse del Nilo. Ma per nulla quelle di qui se ti intendo bene”. (vv. 922-923).
(Torna al documento principale)

