Aracne, Roma, 2006
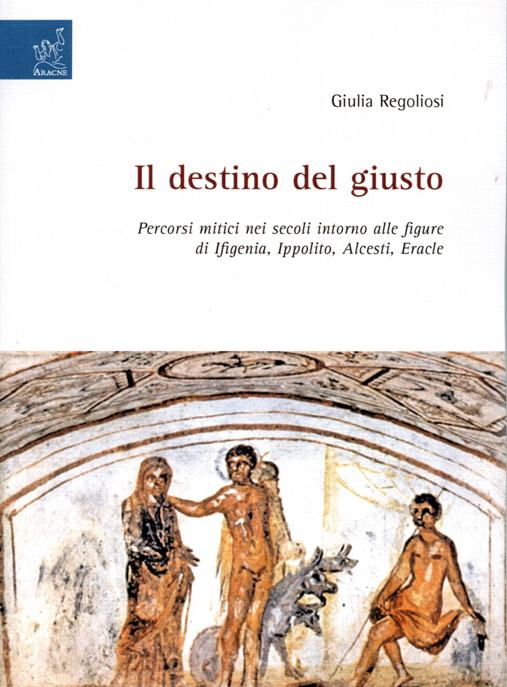
Socrate nell’Apologia dichiara la sua certezza nella corrispondenza fra la volontà dell’uomo e la sollecitudine divina: qualunque cosa succeda all’uomo, sia che viva sia che muoia, è un bene per lui, voluto dagli dèi con interesse attento. Su questa corrispondenza, affermata con fiducia da Socrate, l’uomo greco – e l’uomo di ogni tempo – si è continuamente interrogato, alternando speranza e diffidenza, fede e disperazione. Le quattro figure su cui si svolgono i percorsi mitici di questo libro (ma altre sono via via introdotte) rappresentano dei paradigmi: uomini e donne giusti il cui destino è stato visto nelle diverse varianti ora come salvato ora come desolatamente concluso. Il variare del mito indica le differenti risposte che alla domanda ultima sul rapporto uomo-Dio sono state date nel tempo. Il libro viene proposto anche come lettura per le scuole ed è corredato da un apparato didattico.
Dall’Introduzione
Nulla di male può capitare ad un uomo buono, sia che viva sia che muoia, e le sue vicende non sono trascurate dagli dèi (Platone, Apologia, 40 d).
Socrate è stato sconfitto al processo, e condannato a morte. Rimasto in tribunale dopo la sentenza con i pochi giudici che avevano votato l’assoluzione e con gli amici, si trova di fronte ad un problema che l’ha reso perplesso per tutta quella giornata: perché il suo daimon, la divinità personale che sempre in precedenza l’aveva avvertito quando stava per affrontare una situazione rischiosa, non si è fatto sentire? L’assenza del segno che manifestava l’avvertimento del dio gli ha fatto credere che il processo sarebbe finito bene, con una sentenza di salvezza: è giunta invece la condanna a morte. Ma la delusione si trasforma in una certezza, che egli comunica con decisione ai compagni: l’uomo buono ha l’attenzione degli dèi, nulla avviene per malevolenza o per negligenza da parte loro: dunque anche la condanna a morte è in questo momento il meglio per lui.
La certezza di Socrate non è sempre condivisa dall’uomo antico: che il giusto si salvi o muoia, abbia pienezza di vita o una rimanenza oscura, finisca per sempre o risorga, non viene avvertito come un bene certo e costante, come una scrupolosa e provvidente scelta per il meglio da parte degli dèi. Spesso sono gli dèi stessi a volere la morte, o a permetterla per una noncuranza sbadata, o per una benevolenza incosciente. Molti miti e molte rielaborazioni letterarie presentano diverse varianti, diverse motivazioni, diverse conclusioni che esprimono l’inquieto interrogarsi dell’antico sulla sorte dell’innocente, con tentativi di recuperare la positività del reale o malinconici riconoscimenti d’impotenza e irragionevolezza. I quattro miti che abbiamo scelto (ma molti altri vi si intrecceranno, come si vedrà) sono esempi di questo inquieto interrogarsi, e la presenza di molte varianti che si succedono nelle diverse opere letterarie greche o latine lo testimonia.
Ma non è questo il solo legame fra i quattro miti. Ifigenia e Ippolito hanno tratti comuni: entrambi sono connessi con Artemide: alla dea vergine è dedicata l’uccisione di Ifigenia, fanciulla in età di nozze ma troncata nella sua verginità o irrigidita in essa; alla dea vergine Ippolito consacra liberamente e gioiosamente la propria vita casta, illudendosi di averne in cambio il privilegio dell’affetto. Per entrambi la rovina è dovuta all’operato di Afrodite, la dea dell’amore speculare rispetto ad Artemide, che provocando la guerra di Troia determina (più o meno esplicitamente, a seconda delle varianti) il sacrificio propiziatorio di Ifigenia, e per dignità offesa causa la distruzione di Ippolito. Secondo una variante accolta da Pausania (II, 22, 6-7), i due giovani sono anzi fratellastri: Ippolito figlio di Teseo e di un’amazzone, Ifigenia figlia di Teseo e di Elena, da lui rapita fanciulla e liberatasi del frutto della violenza, che cresce per adozione in casa di Agamennone e Clitennestra.
(…)

