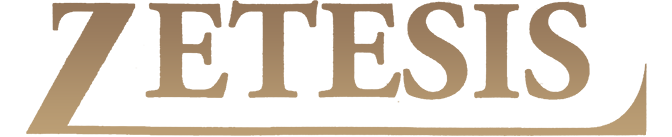Leggiamo la Lettera a Diogneto
All’inizio spieghiamo la scelta di leggere alcuni testi del primo Cristianesimo: finora non abbiamo letto testi cristiani, se non alcuni inni e alcune poesie di Prudenzio, ora abbiamo deciso che era tempo di accostarci a testi cristiani greci in prosa. I prossimi sabati leggeremo opere di Padri Apostolici, la Lettera di Clemente Romano e il Pastore di Hermas, ma abbiamo pensato di cominciare con il testo più famoso, presente in molte antologie scolastiche, anche se non è propriamente annoverabile fra i Padri Apostolici ed è probabilmente posteriore. Diamo per letti i capitoli più noti, quinto e sesto, e scegliamo il secondo, i due capitoli sull’incarnazione di Cristo (settimo e ottavo) e il dodicesimo, uno dei due sicuramente non appartenenti alla Lettera ma interessante per il tema della gnosis.
Segue un’ampia serie di interventi, in cui ciascuno comunica quello che ha saputo o studiato sulla Lettera a Diogneto. La storia del testo, del suo ritrovamento, delle sue vicissitudini; la collocazione cronologica, individuata in un arco di tempo molto ampio, ma più presumibilmente nel secolo terzo; l’identità dell’autore, con diverse ipotesi, l’identità del destinatario e la sua esistenza reale; l’intenzione del destinatario: vuole convertirsi o essere informato? si tratta solo di un colloquio fra persone colte? quindi l’opera è un’apologia o un’esortazione (protreptikon)? il legame fra quest’opera e quella di altri autori, come Giustino e Quadrato. Vengono citati diversi commentatori, in particolare Marrou che ha individuato nel primo capitolo otto domande, a cui l’autore della lettera via via risponde.
Leggiamo il capitolo secondo
- Linguaggio colto, molte figure retoriche
- Grande uso di perfetti
- Se l’epoca è fine secondo, inizio terzo secolo, corrisponde alla seconda sofistica, classicista e atticista
- L’accusa alla religione pagana assume una forma riduttiva, limitata agli idoli;
- si riferisce alla religiosità popolare, che s’identifica in statue, processioni, prosternazioni (proskynesis), offerte sacrificali.
- Non parla di miti, di storie di dèi,
- né dell’adorazione di imperatori
- anche perché sarebbe pericoloso.
- Il riferimento ai martiri colloca la lettera all’epoca delle persecuzioni
- La descrizione degli idoli sordi, ciechi, ecc. ha origini bibliche.
- Nel capitolo ottavo la critica invece è rivolta ai filosofi ionici, che divinizzano fenomeni naturali,
- Questi cercano l’ ἀρχή ,
- ma non accettano una creazione dal nulla.
- Così pure i filosofi che considerano all’origine un demiurgo, ordinatore del caos
- Kαινὸς ἄνθρωπος ricorda il colloquio di Gesù con Nicodemo,
- ‘uomo nuovo’ com’era alle origini
- per ascoltare una nuova dottrina (λόγου καινοῦ).
- ὡμολόγησας indica che il destinatario è una persona reale, alle cui parole l’autore risponde;
- il verbo è comunemente usato anche per indicare l’adesione ad una dottrina o una persona, la confessio;
- del resto il testo è ricco di termini filosofici e teologici, quali ὑπόστασις, εἶδος, φρόνησις.
- Soprattutto colpisce ἐξομοιοῦσθε, l’’indiamento’ che ha un storia filosofica e teologica.
- Che cosa significa ἦν…μεταμορφώμενον? la traduzione della Loeb dà un valore ipotetico, come se l’imperfetto fosse irreale.
- L’insieme dei due verbi costituisce un’unica forma verbale, un piucheperfetto,
- ma il testo è controverso;
- comunque il senso è l’interscambiabilità delle forme degli oggetti dalla stessa materia.
- τυγχάνω costruito col genitivo ‘avere, ottenere’.
- ἐρεῖτε presente (di uso raro).
- φυλάξαντος: perché usa il participio aoristo e non il presente?
- o il futuro come finale?
- l’aoristo è atemporale, indica semplicemente una definizione ‘un uomo di guardia’.
- Che cosa significa αἰνεῖν?
- ‘lodare, elogiare’: ma la tesi è che chiamare dèi questi oggetti è piuttosto offenderli, se li si considera senzienti;
- e se sono insensibili perché sacrificarvi grasso e sangue?
- nell’accusa agli Ebrei dei capitoli successivi il riferimento ai sacrifici è connesso con l’inutilità, perché Dio non ne ha bisogno.
Leggiamo il capitolo settimo
- Πεπίστευνται la forma di perfetto passivo indica il possesso di un lascito, un affidamento;
- diviene soggetto la persona che riceve l’affidamento, mentre la cosa affidata è in accusativo: i Cristiani non hanno avuto l’affidamento dei misteri.
- Il verbo ritorna più avanti τινα τῶν πεπιστευομένων … sempre con l’accusativo, in riferimento ad un elenco di possibili inviati di Dio: ἄγγελον, ἄρχοντα, oppure esseri che amministrano la terra o il cielo.
- Non è chiarissimo a che cosa si riferiscano tutti questi esseri;
- essenzialmente vuole proclamare l’incarnazione di Cristo.
- ἀπερινόητον fa parte dell’elenco di termini negativi con ἀ- che definiscono il Λόγος. Questo termine ricorre anche in preghiere liturgiche, tradotto ‘incomprensibile’; peraltro è la traduzione di questo testo nell’edizione Loeb. Ma la traduzione è scorretta (liturgicamente anche fuorviante): il significato è ‘non raggiungibile pienamente dalla ragione’, mentre ‘incomprensibile’ in italiano sembra indicare un’assurdità.
- ἄβυσσος è parola classica?
- Si trova in poesia, ad esempio nelle Supplici di Eschilo
- e nei Settanta.
- τεχνίτην καὶ δημιουργόν qui ‘demiurgo’ significa creatore.
- qual è il significato della frase τὰ μυστήρια… στοιχεῖα?
- στοιχεῖα sono classicamente gli elementi della natura;
- sono il soggetto, fino alla Rivelazione conservano i misteri (oggetto) del Creatore.
- il Λόγος non è giunto come un tiranno, non viene con la violenza, la paura, la persecuzione, il giudizio.
- il paragrafo 6 è lacunoso: sembra indicare la seconda futura venuta di Cristo (παρουσία) come giudice, ma forse è incompleta la fine del 6 così come l’inizio del 7.
- L’uso del participio presente con valore finale è classico?
- sembra che si trovi spesso; qui si trova con ὡς (sottinteso dove c’è contrapposizione) ma anche senza: κρίνοντα.
- il valore dei martiri come incremento dei Cristiani è un topos degli apologisti.
- δείγματα ‘segni’ della venuta di Cristo.
Purtroppo il tempo ci impedisce di completare la lettura. Rimandiamo alla lettura personale la parte non letta insieme.