Un latino o tanti latini?
E’ la domanda fondamentale che tutti i cultori e gli insegnanti di latino dovrebbero porsi.
Proponiamo come tentativo di risposta alcuni contributi di Moreno Morani che dal 1992 e per diversi anni sono stati ospitati sulle pagine della rivista Nuova Secondaria in una rubrica che aveva il nome di Attraverso il latino.
Si tratta di una serie di contributi brevi, con un supporto critico e bibliografico in genere ridotto, nati come strumento per una riflessione sulla didattica del latino e come proposte di lavoro.
Nuova Secondaria, 15 febbraio 1993, pag. 81
Ogni lingua presenta delle varietà, le cui motivazioni sono da cercare, sinteticamente, in quattro grandi ordini di ragioni:
varietà diacroniche: una lingua si modifica col mutare del tempo, o per il sopraggiungere di mode espressive e di gusti nuovi o per l’esigenza di adattarsi a nuovi contenuti culturali che corrispondono al continuo e naturale allargarsi delle conoscenze umane;
varietà diatopiche, legate alle differenti regioni in cui una lingua viene usata;
varietà diastratiche, legate ai diversi ambienti sociali;
varietà diafasiche, legate alle diverse finalità stilistiche che l’autore del testo si propone: la lingua che si parla è diversa dalla lingua che si scrive, e anche all’interno della lingua scritta esistono varietà: è naturale che la stesura di uno scritto con fini artistici, di una relazione ufficiale, di un’annotazione rapida per uso personale comportino una differente cura nell’evitare espressioni idiomatiche o tendenzialmente volgari.
Poiché il panorama della cultura latina nelle sue espressioni letterarie che si abbraccia nel corso dello studio liceale spazia in un arco che supera il millennio (e più ancora se il docente decide di fare qualche incursione nel latino medievale), ed essendo il latino la lingua di un impero sempre più vasto ed etnicamente differenziato, è chiaro che la lingua risente di queste variazioni, così come le diverse esigenze espressive a cui di volta in volta i diversi autori indirizzano il loro messaggio è ulteriore motivo di varietà. Vanno aggiunte ancora due considerazioni. Innanzitutto la mancanza in epoca antica di mezzi di comunicazione efficaci e penetranti come gli attuali ha impedito che si verificasse una standardizzazione della lingua pari a quella che si ha nelle principali lingue europee moderne, anche se la lingua di Roma, per ragioni politiche e culturali in pari misura, si proponeva come modello, almeno per la lingua scritta: cessate, con la fine dell’impero, le condizioni che favorivano questa iniziale normalizzazione del latino, anche la disgregazione linguistica poté procedere in modo più rapido e definitivo. In secondo luogo, mentre lo studio di una lingua moderna esige un’impostazione sincronica (chi impara l’inglese o il francese ha un chiaro punto di riferimento nella lingua standard moderna), viceversa lo studio di una lingua antica, che ha oltretutto una finalità fondamentalmente culturale (così che l’apprendimento della lingua non è fine a sé stesso, bensì premessa necessaria per uno studio non inadeguato e non superficiale di una cultura complessa e cangiante), deve per forza di cosa avere un’impostazione diacronica. Oltre tutto, il venir meno nell’uso scolastico della versione in latino porta al superamento di passati pregiudizi che, identificando nella lingua della prosa letteraria l’unica varietà di latino “buona”, in contrapposizione ad altre sempre in qualche misura censurabili, orientavano lo studio linguistico all’esclusivo apprendimento di questa.
La domanda del titolo è chiaramente tendenziosa, nonché irrilevante da un punto di vista scientifico: che si chiami anglosassone o inglese antico la lingua del Beowulf ha poca importanza: il Beowulf, Chaucer, Shakespeare, Hemingway rappresentano fasi diverse di una ininterrotta evoluzione linguistica: dando a tutte l’etichetta di inglese si sottolinea la continuità, fermo restando che fra il primo e l’ultimo momento il sistema ha subito trasformazioni tali da renderlo pressoché irriconoscibile. Allo stesso modo, dando l’etichetta di latino tanto alla lingua del vaso di Duenos quanto a quella degli autori dell’età cesariana o delle iscrizioni tarde (per non parlare della lingua del De vulgari eloquentia di Dante), si sottolinea l’esistenza di una unità culturale al di là delle differenze: esattamente come fanno parte della letteratura latina a pieno titolo tanto Catone quanto Ambrogio, nonostante l’enorme diversità di concezione che li separa.
Poste queste premesse, una più completa presa di conoscenze delle varietà del latino è augurabile da parte dell’insegnante. È il fine che si propone la serie di brevi note che abbiamo oggi introdotto.
LATINO: VARIETA’ DIASTRATICHE e DIAFASICHE
Nuova Secondaria, 15 marzo 1993, pag. 45
Chi legge un testo di Plauto ha l’impressione (non scorretta) che la lingua di quest’autore si avvicini all’italiano più della prosa ciceroniana o tacitiana, nonostante la maggior distanza di secoli che ci separa da essa: le ragioni di questo risiedono semplicemente nel fatto che la lingua di Plauto si avvicina maggiormente al latino parlato (dal quale, non lo si dimentichi, hanno preso le mosse le lingue romanze), mentre la prosa d’arte tende sempre più a distanziarsi da questo, fino al raggiungimento, con Cicerone, della sua massima maturità: varie necessità di ordine espressivo (non ultime le esigenze dell’oratoria politica e giudiziaria, nel momento della massima passione politica) portarono, grazie anche a un attento ed accorto riadattamento della lezione greca, alla creazione di un modello di prosa che avrebbe avuto un’influenza determinante sulla prosa colta delle lingue europee attraverso i secoli: caratteristiche precipue del latino ciceroniano sono il ruolo nettamente predominante della lingua di Roma (si ricordino le polemiche ciceroniane sull’urbanitas rispetto alla rusticitas (1) e una severa selezione nei confronti degli elementi di provenienza dialettale o straniera, accolti solamente quando la necessità lo esigeva e altrimenti, se appena possibile, tradotti con equivalenti latini (tecnica del calco). In ogni modo, questo determinò un progressivo allontanamento fra la lingua scritta e la lingua parlata e se, com’è ovvio, non mancarono relazioni e influssi fra l’una e l’altra varietà, la lingua scritta rimase per secoli relativamente stabile nella sua fissità, estranea all’evoluzione e ai cambiamenti che si andavano svolgendo nel latino parlato.
Tra la lingua scritta che si propone fini artistici e la lingua parlata (o volgare) sta la varietà intermedia della lingua comune, con l’eventuale sua articolazione in lingue speciali (la lingua giuridica, la lingua della scienza, la lingua dell’agricoltura e così via), caratterizzate dalla presenza di termini specifici, intesi correttamente da una piccola cerchia di specialisti. E anche nel latino parlato si potranno distinguere diverse varietà: il sermo familiaris (la conversazione colta), il sermo vulgaris (il latino parlato dalla gente comune), il sermo plebeius, con l’eventuale ulteriore accentuazione in senso plebeo del sermo castrensis, la lingua dei militari. Alla varietà più alta del latino parlato, la cosiddetta lingua dell’uso corrente, è dedicata la celebre monografia di J.B. Hofmann (Die lateinische Umgangssprache), che, ad oltre tre quarti di secolo dalla prima edizione, conserva pressoché intatto il suo valore ed è oggi disponibile anche in traduzione italiana (2).
L’interazione fra le diverse varietà linguistiche è continua: vuoi per difetto (iscrizioni ufficiali che denunciano nella scelta di vocaboli o desinenze la scarsa cultura di chi li ha redatti) vuoi per scelta (le rifrazioni, per usare il vocabolo di Hofmann, della lingua parlata sulla lingua scritta: si pensi soltanto alla presenza di sermo castrensis in Catullo).
Ma quanto sappiamo noi del latino non classico? Il limite più grande contro cui ci si imbatte nello studio del latino parlato è costituito dal fatto che tutta la documentazione latina è scritta, e la lingua scritta, anche là dove per scelta tende a rappresentare in modo diretto la lingua colloquiale (Petronio, per fare un nome), non sarà mai riflesso immediato e totale del parlato. Per conoscere il latino parlato dobbiamo dunque ricorrere a documenti che comportano comunque uno scarto rispetto ad esso: le nostre fonti sono costituite dagli autori che per ragioni espressive o di imitazione si accostano alla lingua parlata (ad esempio Plauto), dalle epigrafi, soprattutto le meno impegnative, dai grammatici, soprattutto quando condannano forme proprie della lingua parlata contrapponendole alle forma corretta, dalle continuazioni romanze, che talora ci rimandano a forme sicuramente esistite nella lingua parlata, ma non documentate da nessun testo (ad es. it. alzare, fr. hausser, sp. alzar, che ci obbligano a ricostruire un lat. volgare *altiare, mai attestato). Né va dimenticata l’esistenza di varietà locali: il latino certo non era parlato allo stesso modo a Roma, in Spagna, in Gallia e così via: Gerolamo ci informa di come “ipsa Latinitas et regione quotidie mutetur et tempore” (3). In realtà i tentativi di afferrare nei testi una più o meno marcata coloritura locale hanno dato scarso esito: tanto la Patavinitas di Livio quanto l’Africitas degli autori africani sono per noi fantasmi più che realtà afferrabili. In conclusione, noi siamo in grado di elencare una quantità non trascurabile di elementi disparati che tuttavia, considerati i limiti della documentazione, difficilmente si saldano in un sistema coerente, che permetta uno studio sincronico: un tentativo importante di ricostruire in modo organico e coerente il latino parlato dell’età imperiale è quello di G. Bonfante, la cui tesi di fondo è che a quest’epoca si parlasse una lingua che presentava, soprattutto nella fonetica e nel lessico, moltissimi dei tratti che oggi ritroviamo in italiano .
(1) … neque solum rusticam asperitatem, sed etiam peregrinam insolentiam fugere discamus (Cic., de orat., III 42).
(2) La lingua d’uso latina, Bologna, Pàtron 1985.
(3) In Gal. II 3 (PL 26, 357 A).
Nuova Secondaria, 15 gennaio 1996, pag. 62
Con l’espressione “lingua d’uso” si rende normalmente la parola tedesca Umgangssprache, introdotta dal letterato e poeta G. A. Bürger nel 1794. Il contenuto esatto del termine è difficile da precisare ed è variato nel tempo: all’inizio indicava semplicemente la lingua parlata in opposizione alla lingua scritta, e la fortuna della parola è proporzionale all’interesse crescente con cui la linguistica, dopo essersi concentrata quasi esclusivamente sulle lingue letterarie, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento si fa attenta alla lingua parlata e alla comunicazione orale. In séguito il concetto di “lingua d’uso” viene ulteriormente segmentato, ed essa si contrappone non solo alla lingua scritta, ma anche alla lingua popolare meno elevata. Per restare al latino, con Umgangssprache si fa riferimento al parlato delle classi colte, il sermo familiaris in quanto diverso dal latino parlato dal popolo (sermo plebeius).
Per la lingua d’uso latina è fondamentale il volume di J. B. Hofmann Lateinische Umgangssprache apparso nel 1926 (19503): provano l’interesse del libro, anche a distanza di decenni, le molte traduzioni, fra cui l’italiana (a cura di L. Riccotilli, Bologna, Pàtron, 19852). Alla lettura di questo libro sparisce immediatamente l’impressione (condivisa, ahimè, anche da qualche docente) di un latino lingua paludata e accademica, e si vede come esso si piegava con naturalezza ad essere strumento per la conversazione normale tra persone vive e desiderose di comunicare, né più né meno di qualunque altra lingua, antica o moderna.
La principale difficoltà dell’indagine sulla lingua latina dell’uso è rappresentata naturalmente dal fatto che gli elementi costitutivi del parlato si devono cogliere all’interno di testi scritti: alcuni di questi (commedie, lettere, ecc.) possono avvicinarsi al parlato, altri (il Satyricon di Petronio p.es.) si propongono di rappresentarlo, ma la distanza che separa la parola scritta dalla parola parlata non è colmabile, e pertanto le nostre conoscenze sono sempre un po’ precarie. Tra le caratteristiche della lingua d’uso va segnalata innanzitutto la sua carica affettiva, e di conseguenza la presenza di interiezioni o interrogazioni (ad es. me caecum qui haec ante non viderim Cic., Att. X 10, 1), le frequenti ripetizioni e le ridondanze, la forte spinta verso la frase brachilogica (ad es. iamne autem ut soles? “sei già [noioso] come al solito?” Pl., Truc. 695): è notevole la tendenza ad espressioni estreme, così come in italiano non ci accontentiamo di dire “è bello”, ma tendiamo a dire “è magnifico” o, nello stile più colloquiale, “è un mito”: p.es. Cic., Att. IV 17, 5 moriar, si quidquam fieri potest elegantius o IV 8, 1 nihil quietius, nihil alsius, nihil amoenius. Per accentuare l’enfasi si usano avverbi come mirifice o horribiliter, e accanto a multum sta il colloquiale insanum (estur insanum bene “si mangia bene da matti”, Pl., Mil. 24). Si usa nihil, nullus, numquam per il semplice non; i grecismi sono assai più frequenti che nella lingua scritta.
Altra caratteristica è la tendenza a scomporre la frase in parti brachilogiche embrionali separate da pause: per dirla con Hofmann, «la singola frase sottoposta all’azione delle brusche scosse affettive viene squarciata e atomizzata nelle sue parti» (p. 249): p.es. cupit credo triumphare Cic., Att. I 20, 5. Il tema della proposizione è collocato all’inizio, con l’eventuale rinvio in seconda sede della congiunzione o del pronome che dovrebbe introdurre la subordinata: Cic., Att. XIII 18 vides, propinquitas quid habeat. Nota Hofmann che in due diverse lettere ad Attico (XIII 3 e XIII 15) ricorre una frase quasi identica: Attica mea, obsecro te, quid agit? e quid agit, obsecro te, Attica nostra? Nel secondo caso si ha la collocazione normale, mentre nel primo la collocazione delle parole e l’uso di mea rivela una maggiore carica di affettività. L’asindeto è frequentissimo, e poco rilievo ha in genere l’ipotassi.
Nella tendenza generale all’economia rientra l’utilizzazione intensiva di verbi di valore generale come facere, dare, esse: Cic., Att. I 7, 1 apud matrem recte est. I pronomi dimostrativi sostituiscono il nome degli oggetti: in frasi come haec hinc propere amolimini (Pl., Most. 391) l’indicazione deve essere accompagnata da una mimica che il testo scritto è in grado solo di suggerire. Il risparmio coinvolge spesso elementi che il contesto permette di sottintendere: Cic., Att. VI 2, 6 In Ciliciam cogitabam “pensavo di andare in Cilicia” e, più vigoroso, Cic., Att. XIII 40, 1 Itaque nuntiat Brutus, illum ad bonos viros? sed ubi eos? “e così dice Bruto che quello vuole rientrare tra i moderati? e dove li troverà?”
L’individuazione dei tratti comuni della lingua parlata consente anche una valutazione meno approssimativa delle scelte stilistiche di molti autori, e permette di cogliere caratteristiche del parlato anche in testi di massimo impegno. Nell’Eneide (II 670), nella fase concitata che precede la decisione di Enea di fuggire, il discorso del protagonista termina con le parole Numquam omnes hodie moriemur inulti: l’uso di numquam per non e soprattutto di hodie col valore non di avverbio temporale, bensì di semplice asseverativo prossimo a hercle («non tempus significat, sed iracundam eloquentiam» nota un commentatore antico), è tipico della lingua familiare.
Nuova Secondaria, 15 ottobre 1994, pag. 69
Se lo studio liceale del latino non mira solamente ad avviare alla conoscenza di testi rappresentativi per contenuto di pensiero e valori formali, ma si propone anche di far conoscere allo studente la cultura antica in tutte le sue sfaccettature, dovrebbe trovare uno spazio, per quanto piccolo e limitato, anche la lettura dei testi epigrafici. Parliamo qui delle iscrizioni unicamente dal punto di vista linguistico e letterario, prescindendo dal loro valore di documento storico, spesso utile integrazione di dati che le altre fonti ci presentano in modo parziale o confuso.
L’interesse della lettura di testi epigrafici è duplice. Da una parte il latino delle epigrafi, generalmente più libero e più vicino alla lingua parlata e meno condizionato dalle esigenze puristiche e di perfezione formale che presiedono alla stesura dei testi letterari, ci presenta quasi dal vivo l’affermarsi di innovazioni linguistiche proprie dell’evoluzione romanza permettendoci di datare l’inizio dei mutamenti. Sappiamo così che, ad esempio, nel I sec. d.C. i dittonghi ae, oe erano pronunziati correntemente e, ovvero che attorno al 450 in Italia c era già pronunziata palatale dinanzi a vocale della serie anteriore (e, i): leggiamo infatti intzitamento in un’iscrizione di quest’epoca rinvenuta ad Ariccia. Dallo studio del materiale epigrafico ricaviamo che in Italia la pronunzia volgare del latino dell’età imperiale presenta tratti che in modo sorprendente l’avvicinano alla pronunzia italiana attuale (per esempio nel venir meno delle occlusive finali: canta e ama per cantat e amat, o nell’assimilazione di nessi come ps e cs, pt e ct in ss, tt: issu in luogo di ipsum), o che il sistema della flessione nominale mostrava i primi segni di collasso di fronte all’imporsi del sintagma preposizione + sostantivo, o altro ancora.
Ma non minore è l’interesse di natura culturale. Facciamo riferimento a due raccolte di recente pubblicazione e facilmente reperibili: Iscrizioni funerarie romane, a cura di L. Storoni Mazzolani (Milano, Rizzoli, 1991) e Graffiti latini. Scrivere sui muri a Roma antica, di L. Canali e G. Cavallo (Milano, Bompiani, 1991). Scrive il Cavallo nell’introduzione a quest’ultimo volume (pag. 11) che “dietro i graffiti si intravede un mondo brulicante e colorato”, e che i riferimenti al quotidiano rivelano una “ridda di contenuti” quanto mai varia, così come diversissimo è il livello di cultura e la competenza linguistica di chi produce questi testi. Ma quando dall’effimero (propaganda elettorale, sospiri e pene d’amore, elogi ai vip del tempo) si passa, con molta gradualità, a testi più impegnativi per il contenuto e la destinazione, allora diviene sensibile il tentativo di adeguarsi ai modelli del latino più elevato, facendone proprie le caratteristiche e le possibilità espressive, pur nell’incertezza di esiti che comportano spesso scelte fono-morfologiche o sintattiche estranee (e talora addirittura contrarie) alla tradizione ciceroniana o virgiliana. Gli epigrammi funerari ci mettono di fronte a personaggi di condizione sociale non elevata (per la maggior parte le iscrizioni tombali di Roma sono di schiavi o di liberti) che mostrano una conoscenza notevole della produzione letteraria “colta”: ma non soltanto sono interessanti i riecheggiamenti dei poeti più svariati: spesso percepiamo sullo sfondo grandi trasformazioni storiche o ideali, col diffondersi di idee e di correnti di pensiero che oltrepassano i limiti della stretta cerchia dei letterati di professione.
Una lettura (beninteso senza eccessi) di testi epigrafici potrà, in conclusione, essere di conforto per l’allievo. Gli rivelerà come i testi proposti dal manuale letterario non siano frutto di personaggi isolati da un contesto, bensì rappresentino, con superiore pienezza e capacità espressiva, tensioni e ideali condivisi dalla società del tempo. D’altro canto l’allievo coglierà nell’uso quotidiano di parlanti nativi quella variegata e complessa realtà linguistica che è il latino: non un’entità astratta formata da una filza di regole disarticolate, immotivate, immutabili, bensì un sistema che presenta nell’uso varietà differenti in armonia con le finalità espressive del parlante. Si avverte come sia nitido lo stacco fra lingua parlata e scritta, e come quest’ultima rappresenti un codice a cui è necessario rapportarsi nella produzione di testi che si propongono di veicolare messaggi destinati a durare nel tempo: un codice però sufficientemente noto e diffuso e, pur con fatica e inevitabili approssimazioni, inteso e praticato anche da persone di condizione sociale e culturale non elevata.
Nuova Secondaria, 15 novembre 1994, pag. 69
Si è accennato al riecheggiamento di motivi letterari in carmi epigrafici. Diamo qui qualche esempio sommario di quest’affermazione. Un’iscrizione del IV sec. (CLE 1979 Bücheler) trovata a Roma nei pressi della via Salaria e per vari indizi ritenuta proveniente da ambiente cristiano, si apre con queste parole: “Heu, cui miseram linquis, karissime coniunx? | quid sine te dulce rear, quid amabile credam? | cui vitam servo, quod non sequor, improbe, funus?” Palese reminiscenza delle parole con cui Didone apostrofa Enea nel momento in cui questi la avverte della sua intenzione di partire: “heu cui me moribundam deseris, hospes?” (En. IV 323), e allo stesso passaggio si rifà l’improbe del v. 3: lo ritroviamo in En. IV 386 egualmente collocato nella quinta sede dell’esametro: “dabis, improbe, poenas“. Ma il possesso di riferimenti letterari (si moti anche l’uso del poetico linquis per il più comune relinquis) non mette lo scrivente al riparo dalle incertezze metriche: sia nel primo sia nel secondo esametro manca mezzo piede.
Una lapide di epoca augustea recentemente rinvenuta a Roma (in Iscrizioni funerarie romane, a cura di L. Storoni Mazzolani, Milano, Rizzoli, 1991, n. XXIV) ci propone il seguente epigramma: “Flevi, Martha, tuos extremo tempore casus | ossaque composui. Pignus amoris habes“: oltre alla perfetta fattura metrica del distico, espressioni come flere casus e pignus amoris denunciano reminiscenze letterarie (rispettivamente Ovidio, Amores I 12, 1 e Virgilio, En. V 538). Eppure sia il dedicatario sia la defunta sono persone di condizione servile: Nebullus Marthae conservae.
Un altro personaggio, Domizio Tiras, nell’epigrafe funerarie della figlia (op. cit. n. LXXXI = CLE 1490) riprende con commossa partecipazione una metafora consueta nella letteratura, quella che paragona le vicende della vita al ciclo perenne delle natura: anche qui un distico elegiaco, con l’esametro metricamente scorretto: “Quo modo mala in arbore pendunt, sic corpora nostra: | aut matura cadunt aut cito acerva ruunt“. In acerva si ha un fenomeno linguistico largamente documentato in epigrafi imperiali, il betacismo, per cui b assume una pronunzia fricativa v e si confonde con u semivocalica, che nel frattempo aveva assunto la medesima pronunzia: il fenomeno ha lasciato ampie tracce in spagnolo (boda ‘nozze’ da vota).
La sorella di Decimo Terenzio Genziano, importante personaggio dell’età traianea che ricoperse cariche politiche e militari e si segnalò nelle campagne partiche, fa incidere il nome di questi su una piramide egiziana (op. cit. n. LXXVI = CLE 270): “Vidi pyramidas sine te, dulcissime frater, | et tibi quod potui, lacrimas hic maesta profudi | et nostri memorem luctus hanc scalpo querelam. | Sic nomen Decimi Gentiani pyramide alta | pontificis comitiquis tuis, Traiane, triumphis, | lustra[que] sex intra censoris consulis exst[et]”: se il v. 2 si rifà a Ovidio (Fasti V 472) e il 3 ad Orazio (Odi III 11, 51 s.) e nel v. 5 è rilevante l’allitterazione tuis Traiane triumphis, tutto il carme meriterebbe di essere accostato, per la somiglianza della situazione e per la tensione espressiva che trascende il carattere occasionale dell’epigrafe, al c. 101 di Catullo.

Ma spesso è l’effimero a prevalere, e allora la reminiscenza letteraria si risolve in scherzo: come quello di un lavandaio di Pompei, che scrive sui muri della sua bottega: “Fullones ululamque cano, non arma virumque” (CLE 1936: la civetta, ulula, è il simbolo di Minerva artigiana); o il don giovanni di provincia, dai gusti aristocratici e un po’ tirchio, che ci ha lasciato questo distico (CLE 940): “Omnia formonsis cupio donare puellis | sed mihi de populo nulla puella placet” (noteremo l’uso di formosus, scritto qui erroneamente con –ns-: usato soprattutto per indicare bellezza fisica – basti per tutti il rinvio a Catullo c. 86 – è termine di un registro linguistico parlato, ma scelto, collocandosi a metà fra pulcher e bellus: la parola è rimasta nelle zone marginali del mondo neolatino, l’iberica e la balcanica, che spesso nel lessico si rifanno a un uso linguistico più scelto di quello rimasto in Italia e in Gallia): il breve carme ha il sapore di una risata, sul tipo del “torrei le donne giovani e leggiadre” di Cecco Angiolieri. Maggior tenerezza in questo distico di un innamorato che ritiene la sua ragazza splendida come la Venere di Apelle (CLE 2057, Pompei): “Si quis non vidit Venerem quam pinxit Apelles, | pupa mea aspiciat: talis et illa nitet” (pupa mea per pupam meam: la caduta di –m finale è largamente attestata nelle iscrizioni di Pompei: pupa è fortemente affettivo: ‘la mia bambina’: un’altra iscrizione pompeiana, espressione di una latinità più bassa, inizia con: pupa, que bela is “bimba, che sei bella”). E c’è chi, in una lingua più raffinata, si mostra preoccupato di tutto questo gran scrivere sui muri e lo dice con un distico scherzoso (CIL IV 1904): “Admiror, pariens, te non cecidisse ruinis, | qui tot scriptorum taedia sustineas
Nuova Secondaria, 15 febbraio 1996, pag. 66
È prassi profondamente radicata nella didattica del latino quella di proporre tra i primi testi di lettura, non appena gli allievi sono in grado di seguire un semplice passo di prosa, i Vangeli. Tale scelta sembra produttiva e condivisibile non solo per ragioni di ordine linguistico: i Vangeli costituiscono un testo ormai estraneo all’orizzonte culturale di molti giovani, ed è colpa grave della scuola italiana quella di non dare spazio, in nessun ordine di scuola e in nessuna disciplina, a una seria lettura della Bibbia, quasi che essa non costituisse uno dei pilastri della cultura occidentale e non fosse essa stessa un testo di altissimo valore letterario, e come se fosse possibile accostare i documenti delle letterature e delle arti europee senza conoscerla.
Dal punto di vista linguistico i Vangeli si presentano come un testo accessibile: specialmente i passi narrativi hanno una sintassi semplice, e almeno per quanto riguarda la comprensione strettamente letterale non dànno adito in genere a difficoltà gravi. Diverso il discorso per altri libri del Nuovo Testamento, che possono presentare difficoltà concettuali tali da sconsigliarne la lettura ai «tirones». Non sono però inopportune alcune premesse. In certe antologie traspare l’idea che questa lettura sia un ripiego, in mancanza di meglio e col rammarico di non poter ancora accostarsi a testi di latino “vero”. L’osservazione, in sé legittima, di una diversità fra latino dei Vangeli e latino ciceroniano non dovrebbe contenere nessuna connotazione negativa: quello dei Vangeli non è un “brutto latino”, ma un latino che appartiene a un registro diverso, più prossimo alla lingua popolare e parlata, e che, sia pure attraverso la mediazione degli originali greci, risente di influssi semitici. Si potrebbe rovesciare il pregiudizio negativo e dire che è la prosa dei Vangeli ad essere vicina al latino “vero”, quello dell’uso vivo, più della prosa d’arte, che col suo ricorso all’ipotassi, col richiamo a ideali di eleganza e concinnitas, con la sua rigorosa selezione puristica rappresenta il momento finale di un lungo processo di elaborazione e un sostanziale allontamento dalla lingua dell’uso. Se il periodare complesso è creazione originale di Atene e Roma trasmessa poi alla prosa europea, i Vangeli ci offrono un modello in parte estraneo rispetto a questa linea, e mostrano come si possano raggiungere momenti di tensione narrativa e concettuale elevata pur senza rifarsi ai modelli della prosa d’arte greca o romana.
Sarebbe scorretto accentuare il carattere basso del latino dei Vangeli e ingenuo addebitare a una presunta scarsa cultura di chi li ha scritti o tradotti l’appartenenza di questi a un registro linguistico diverso da quello della prosa d’arte.
Certo questo discorso non vale per la traduzione. Gerolamo, autore colto, in possesso di uno stile elegante e raffinato, sarebbe stato benissimo capace, se l’avesse voluto, di adeguare i Vangeli ai canoni della prosa d’arte: se non lo fece, fu per una scelta precisa. Sarebbe interessante, e sicuramente efficace nel quadro di un insegnamento linguistico non frettoloso, istituire un confronto (anche di poche righe) fra la prosa dei Vangeli e la prosa di altri testi di Gerolamo: la differenza balzerebbe agli occhi. Mentre quasi tutti i libri del Vecchio Testamento furono ritradotti direttamente dagli originali (ebraici, aramaici o greci), Gerolamo non ritenne necessario dare una traduzione nuova dei Vangeli, bensì sottopose a revisione accurata le versioni circolanti (la cosiddetta Vetus Latina), eliminando scorrettezze linguistiche e migliorando l’aspetto formale. L’obiettivo principale di Gerolamo però non era tanto la revisione stilistica delle versioni, quanto l’assicurare una piena rispondenza fra traduzione e originale anche attraverso un controllo critico del testo greco utilizzato: la traduzione della Bibbia doveva essere precisa e aderente all’originale, ma soprattutto riflettere un testo corretto, non sfigurato da lezioni inattendibili o secondarie: a quest’opera impegnativa Gerolamo dedicò più di venti anni, e il suo modo di procedere (esposto nella lettera a Pammachio, scritta anche per difendersi dalle critiche che gli erano state rivolte [1]) è rigoroso.
Poste queste premesse, i Vangeli risultano un testo ideale, che risponde alle più diverse istanze didattiche. Da una parte abbiamo, come detto, una prosa semplice e facilmente leggibile, dall’altra la revisione gerolamiana è garanzia della correttezza e della pulizia della lingua che abbiamo di fronte. Non è un caso se la versione latina della Bibbia rivista o rifatta da Gerolamo, pur con le inevitabili imprecisioni o difetti, è divenuta la Vulgata, che ha eliminato le altre preesistenti versioni e si è imposta come la versione ufficiale della Chiesa occidentale. Sulle peculiarità linguistiche dei Vangeli torneremo più diffusamente in un successivo intervento.
(1) L’ep. XLIX (Apologeticum ad Pammachium) è facilmente accessibile nell’edizione antologica delle lettere di Gerolamo curata da C. Moreschini e con traduzione di R. Palla (Milano, Rizzoli, BUR, 1989, pp. 264-335).
Nuova Secondaria, 15 giugno 1996, pag. 92
Un particolare che balza immediatamente agli occhi, nella lettura dei Vangeli, è l’uso molto largo di proposizioni introdotte da quod o quia (talora anche quoniam), laddove nell’uso classico si avrebbero delle infinitive: videns quod sapienter respondisset dixit illi (Mc. 12, 34); scimus quia a Deo venisti (Io. 3, 2); nolite putare quoniam veni solvere legem (Mt. 5, 17). La preferenza per le proposizioni esplicite corrisponde a un’evoluzione che appare sempre più intensa nei testi. Ad es. il tipo scio quod (con l’indicativo o il congiuntivo ), compare con frequenza sempre maggiore a partire da Petronio e nell’età imperiale ha un discreto rilievo anche in testi di prosa impegnata: scio quod nulla communio luci et tenebris sit (Gerol., ep. XI 1); credimus et tenemus et fideliter praedicamus quod pater genuerit Verbum (Agost., de civ. Dei XI 24) .
In sostanza, la Vulgata presenta un costrutto che si è già imposto nella lingua dell’uso e sta entrando in modo prepotente nella lingua letteraria. La stessa osservazione può essere estesa a gran parte della sintassi: non vi è, si può dire, costruzione che non si trovi comunque in autori precedenti. Ad esempio l’uso del proibitivo col congiuntivo presente (che coesiste comunque col perfetto: Mc. 10, 19 ne adulteres, ne occidas, ne fureris, ne falsum testimonium dixeris, ne fraudem feceris), pur appartenendo a un registro più colloquiale, ha dietro le spalle una lunga tradizione letteraria. Per contro vengono evitate costruzioni che, pur avendo già attestazioni nella lingua scritta, sono ritenute scorrette o eccessivamente volgari: è il caso dell’infinito preceduto da preposizione, che ricorre in Tertulliano (propter … videre ac videri) e nella Vetus Latina (Io. 6, 52 dare ad manducare), ma viene eliminato nella Vulgata (dare ad manducandum).
Anche molte scelte lessicali riflettono evoluzioni che si andavano affermando nella lingua dell’epoca: ad es. la presenza di manducare (Io. 6, 58 qui manducat hunc panem) attesta la decadenza di edo. L’uso di crescere, a fronte della quasi completa scomparsa di augere (solamente il composto adaugeo in Lc. 17, 5 adauge nobis fidem), mostra la vitalità del primo rispetto al secondo. Lo stesso vale per quomodo nel senso di ‘come’ (Io. 14, 27 non, quomodo mundus dat, ego do vobis) o di quando nel senso di cum. La presenza di grecismi in numero apparentemente superiore al consueto (angelus, parabola, propheta, synagoga, cathedra, baptizare, ecc.) è un altro tratto che avvicina lo stile dei Vangeli alla lingua parlata, meno condizionata da esigenze puristiche rispetto alla lingua letteraria. Ma in conclusione, per tutti questi aspetti la lingua dei Vangeli non si scosta granché dal latino del suo tempo. Trascuriamo per il momento i problemi, molto complessi, riguardanti i tecnicismi cristiani, ripromettendoci di esaminare in altra circostanza il complesso problema del “latino cristiano”.
Elemento caratteristico è invece la presenza di numerosi semitismi, sia pure mediati attraverso la redazione originale greca. Il presentarsi di brevi periodi introdotti da et, spesso con ordine di parole verbo – soggetto – oggetto – elementi accessori (p.es. Lc. 2, 41 et ibant parentes eius per omnes annos in Hierusalem) denunzia l’influsso della sintassi semitica. Semitismi si colgono nella presenza di prestiti (amen, sabbatum, pascha) o di calchi (ad es. debitum nel senso di ‘peccato’: Mt. 6, 12 dimitte nobis debita nostra). Citiamo ancora alcune fra le particolarità morfosintatiche più vistose: l’uso del positivo invece del comparativo (Mc. 9, 45 bonum est tibi claudum introire in vitam aeternam, quam duos pedes habentem mitti in gehennam); il secondo termine di paragone con ab (Lc. 19, 14 descendit hic iustificatus in domum suam ab illo [‘più di quello’, cioè del fariseo]); in + abl. con valore strumentale (Mt. 4, 4 = Lc. 4, 4 non in pane solo vivet homo); l’uso di factum est seguito da una proposizione coordinata con et (Lc. 5, 17 et factum est in una dierum et ipse sedebat docens), o addirittura per asindeto (Mc. 1, 9 et factum est in diebus illis venit Iesus), costruzione quest’ultima non ammessa dall’uso ebraico, ma introdotta in greco con la versione dei Settanta; i pleonasmi dei verbi di dire che introducono discorsi diretti o indiretti, riflesso di un’analoga costruzione semitica (Lc. 20, 2 aiunt dicentes ad illum); l’uso di participi (o di sostantivi astratti) corradicali del verbo principale, riflesso del cosiddetto infinito assoluto semitico che conferisce enfasi all’espressio-ne (Mt. 13, 14 auditu audietis et non intellegetis, et videntes videbitis et non videbitis); i frequenti scambi dei tempi, non di rado usati con valore sensibilmente diverso da quello usuale. Qualche volta nell’originale greco l’influsso semitico si coglie in misura più cruda che nella versione latina, nella quale si tiene conto maggiormente delle esigenze stilistiche e morfosintattiche della lingua d’arrivo: basti l’esempio di Apoc. 4, 9-10, ove i futuri del greco sono correttamente resi in latino con imperfetti (cum darent … procidebant).
Nuova Secondaria, 15 giugno 1997, pag. 65, col titolo Nei Vangeli
Tra le molte possibilità che il testo evangelico offre, ne segnaliamo ancora una, che proponiamo come possibile percorso di unità didattica nelle classi del triennio ove vi sia un insegnamento di greco. La presenza di più versioni antiche a fronte del medesimo originale greco permette agli allievi due ordini di considerazioni: l’enucleazione di differenze sintattiche fra lingua greca e latina e il riscontro in latino di varietà linguistiche più o meno elevate, con l’eventuale ulteriore verifica della continuità storica nella nostra lingua degli elementi individuati come volgari. Tentiamo, attraverso un paio di esempi, di spiegarci meglio e premettiamo che, senza entrare nel merito di questioni complicatissime su cui esiste una bibliografia sterminata, ci accontenteremo di assumere l’esistenza di due versioni principali, tra loro indipendenti, che precedono la Vulgata (l’Afra e l’Itala) e la dipendenza della Vulgata dalla seconda di queste. Come strumento di lavoro consigliamo il manuale, ricco di notizie e facilmente accessibile, di A. Ceresa-Gastaldo, Il latino delle antiche versioni bibliche (Roma, Ed. Studium, 1975), ove sono recati e analizzati vari passi del Nuovo e Antico Testamento nel testo originale e nelle diverse versioni antiche; ad esso si può affiancare il bel libro di E. Valgiglio, Le antiche versioni latine del Nuovo Testamento (Napoli, Koinonia, 1985), che offre un ampio esame linguistico delle versioni pregerolamiane.
In Io. 2, 13 l’Itala ha ascendit Iesus in Hierosolymis: si nota sia l’uso di premettere in ai nomi di città sia la confusione fra nozione di stato e di moto a luogo: entrambe le tendenze hanno riscontro, e si sono imposte, nelle lingue romanze (l’it. in Gerusalemme può esprimere sia il moto sia lo stato): la Vulgata ha ascendit Hierosolyma Iesus.
Parimenti in Io. 20, 27 l’Afra ha adfers [indicativo in luogo dell’imperativo] manum tuam et mitte in latere meo, mentre e l’Itala e la Vulgata hanno adfer manum tuam et mitte in latus meum.
L’esame di Mc. 14, 35 mostra la difficoltà di rendere in latino il participio aoristo greco: l’assenza dell’aoristo e l’uso più limitato dei participi in latino rispetto al greco obbliga gli interpreti a soluzioni che presentano comunque degli inconvenienti. Il comportamento delle tre versioni è di volta in volta diverso: l’Afra coordina il participio al verbo finito (processit pusillum et cecidit), l’Itala si avvale di un participio presente (adcedens paulum procidit), la Vulgata fa corrispondere al participio greco una proposizione subordinata esplicita (cum processisset paululum, cecidit). Subito dopo (v. 40) il problema si ripresenta: il comportamento delle due versioni pregerolamiane è analogo (et venit et invenit illos l’Afra; et veniens invenit eos l’Itala), mentre è diverso il comportamento della Vulgata, che può avvalersi qui di una forma participiale che pare più aderente alla forma greca (et reversus denuo, invenit eos); si osserverà anche che Gerolamo è l’unico dei tre a riprendere con denuo il pálin dell’originale, tralasciato dai precedenti interpreti. Ne emerge immediatamente sia lo scrupolo di precisione di Gerolamo (che sottolinea nella lettera a Pammachio la necessità di conservare fedelmente ogni particolarità del testo sacro, in cui tutto, compreso l’ordine delle parole, è mistero) sia la sua attenzione nel valutare gli strumenti espressivi che la lingua latina gli mette a disposizione e la loro adeguatezza alla resa del greco.
In Io. 20, 29 il perfetto gr. pepísteukas è reso con un presente dall’Afra (credis) e un perfetto (credidisti) dall’Itala e dalla Vulgata, che hanno meglio percepito il valore aspettuale della forma latina e la sua sostanziale corrispondenza con la forma greca. Subito dopo, dove l’originale ha due participi aoristi sostantivati (idóntes … pisteúsantes), l’Afra rende sorprendentemente il secondo con un futuro (beati qui non viderunt et credent), mentre l’Itala e la Vulgata mantengono il parallelismo (beati qui non viderunt et crediderunt).
Numerosi i casi in cui la Vulgata elimina scorrettezze morfosintattiche ravvisabili in una o in entrambe le versioni precedenti: p. es. Mc. 14, 39 l’infinito finale delle versioni antiche (abit adorare l’Afra e abiit orare l’Itala) non trova corrispondenza nella Vulgata che ha abiens oravit. In Lc. 18, 13 leggiamo percutebat nell’Afra e regolarmente percutiebat nelle rimanenti versioni; in Io. 20, 26 leggiamo ienuis clausis nell’Afra e ianuis clusis (it. chiuso!) nell’i: solamente Gerolamo ha il corretto ianuis clausis. Per contro in Lc. 18, 9 la Vulgata ha il grecismo parabolam istam, dove le restanti versioni hanno il termine schiettamente latino similitudinem istam: segno evidente che ormai gr. parabolé aveva assunto un contenuto tecnico preciso che il corrispondente latino non era in grado di comunicare in modo adeguato.
Le osservazioni che si possono ricavare, come si vede, sono numerosissime: sta solo alla fantasia del docente approfondire, rielaborare, proseguire gli spunti qui offerti.
Nuova Secondaria, 15 febbraio 2001, pag. 88-89
Anche in latino esistevano linguaggi settoriali, funzionali cioè alla comunicazione di contenuti molto specifici in un ambito preciso. Caratteristica dei linguaggi settoriali è di essere carichi di tecnicismi e tendenzialmente chiusi: preoccupazione fondamentale del parlante è di rendere la propria comunicazione concisa ed efficace, evitando giri di parole inutili e ambiguità pericolose; peraltro l’inevitabile interazione con la lingua comune fa sì che termini o modi di dire propri del linguaggio settoriale si affermino anche in un ambito più generale.
Un accenno all’esistenza di lingue settoriali in latino non dovrebbe mancare, anche se certo lo studio del latino tecnico non può essere fine a sé stesso. Anni fa erano diffuse nel liceo scientifico antologie di testi di prosa scientifica, in quanto si riteneva che una scelta siffatta corrispondesse meglio all’identità di questo indirizzo di studi: questo modo di procedere si è rivelato errato ed è stato quasi abbandonato negli anni successivi. Da una parte, infatti, non si capisce perché proprio nello studio del latino il liceo scientifico dovrebbe affermare una vocazione specifica che non risulta neppure presa in considerazione in altre discipline di area umanistica come la storia o la filosofia; in secondo luogo, nell’esiguità di tempo a disposizione per la lettura non è coerente valorizzare Vitruvio o Columella a scapito di prosatori culturalmente più significativi come Tacito o Seneca. Poste queste premesse, un’incursione in qualche linguaggio settoriale, limitata alla lettura intelligente di qualche brano di versione, è ipotesi da non scartare .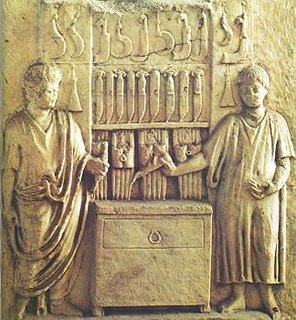 L’esempio che proponiamo è quello della medicina, e l’opera a cui facciamo riferimento è quella di Celso, autore ben rappresentato nelle antologie di versioni, e addirittura prescelto per il brano della maturità magistrale in anni recenti: ma senza un richiamo almeno iniziale al linguaggio della medicina non si potrebbero affrontare, per esempio, il finale di Lucrezio o tante pagine di Seneca in cui viene istituito e perseguito con descrizioni realistiche il paragone tra malattie del corpo e dell’anima. Noteremo innanzitutto nella lingua di Celso un carattere meno lontano dalla lingua dell’uso parlato di quanto avvenga nella prosa letteraria: p.es. ricorre l’uso di si per introdurre l’interrogativa indiretta o di cum con l’ablativo per esprimere il mezzo. Lo sforzo di comunicare con precisione porta a mettere sullo sfondo altre preoccupazioni stilistiche: da qui l’impressione di trascuratezza che si avverte. La presenza di grecismi è significativa (glaucoma, collyrium, emplastrum, dyspepsia, ecc.): poiché sempre nei linguaggi settoriali sono presenti termini stranieri che provengono dalle lingue che hanno goduto di particolare prestigio nell’ambito particolare (si pensi al francese nella moda, all’italiano nella musica, all’inglese nello sport o nell’informatica), risulta chiara la dipendenza di Roma dalla Grecia nell’arte medica, a lungo studiata e praticata da greci, spesso di condizione servile. I tecnicismi possono presentarsi in due modi: o come termini di uso limitato, propri di quel determinato linguaggio settoriale, o come termini della lingua comune usati con un significato particolare. Esempi del secondo tipo sono ad es. loci (per indicare parti del corpo) o causa (per indicare la malattia), quest’ultimo ellissi (fenomeno frequente nelle lingue tecniche) da causa morbi: a questo valore tecnico di causa si riallaccia il derivato causarius, la persona facilmente soggetta a malattie (analoga la derivazione di it. cagionevole da cagione ‘causa’). In fracta o contusa usati isolatamente si dovrà sottintendere membra: l’uso ripetuto di aggettivi o participi sostantivati è caratteristica notevole del linguaggio medico.
L’esempio che proponiamo è quello della medicina, e l’opera a cui facciamo riferimento è quella di Celso, autore ben rappresentato nelle antologie di versioni, e addirittura prescelto per il brano della maturità magistrale in anni recenti: ma senza un richiamo almeno iniziale al linguaggio della medicina non si potrebbero affrontare, per esempio, il finale di Lucrezio o tante pagine di Seneca in cui viene istituito e perseguito con descrizioni realistiche il paragone tra malattie del corpo e dell’anima. Noteremo innanzitutto nella lingua di Celso un carattere meno lontano dalla lingua dell’uso parlato di quanto avvenga nella prosa letteraria: p.es. ricorre l’uso di si per introdurre l’interrogativa indiretta o di cum con l’ablativo per esprimere il mezzo. Lo sforzo di comunicare con precisione porta a mettere sullo sfondo altre preoccupazioni stilistiche: da qui l’impressione di trascuratezza che si avverte. La presenza di grecismi è significativa (glaucoma, collyrium, emplastrum, dyspepsia, ecc.): poiché sempre nei linguaggi settoriali sono presenti termini stranieri che provengono dalle lingue che hanno goduto di particolare prestigio nell’ambito particolare (si pensi al francese nella moda, all’italiano nella musica, all’inglese nello sport o nell’informatica), risulta chiara la dipendenza di Roma dalla Grecia nell’arte medica, a lungo studiata e praticata da greci, spesso di condizione servile. I tecnicismi possono presentarsi in due modi: o come termini di uso limitato, propri di quel determinato linguaggio settoriale, o come termini della lingua comune usati con un significato particolare. Esempi del secondo tipo sono ad es. loci (per indicare parti del corpo) o causa (per indicare la malattia), quest’ultimo ellissi (fenomeno frequente nelle lingue tecniche) da causa morbi: a questo valore tecnico di causa si riallaccia il derivato causarius, la persona facilmente soggetta a malattie (analoga la derivazione di it. cagionevole da cagione ‘causa’). In fracta o contusa usati isolatamente si dovrà sottintendere membra: l’uso ripetuto di aggettivi o participi sostantivati è caratteristica notevole del linguaggio medico.
Altro carattere comune delle lingue settoriali è il ricorso a metafore. L’esatto significato originario e l’etimologia di ieiunus ci sfuggono: forse la parola indicava in origine i campi aridi e poco produttivi in opposizione a umidus. Nella medicina la coppia ieiunus : umidus viene ripresa con valore diverso: ieiunus è il corpo smagrito per mancanza di cibi o liquidi, e si oppone a umidus ‘linfatico’. In séguito ieiunus viene a indicare la persona che non ha ingerito cibi, e in questo senso il termine passa alla lingua comune, ove è proseguito fino ai nostri giorni ad es. nel franc. jeûne o nell’ital. digiuno (attraverso una fase intermedia non documentata *gigiuno). Partendo dal valore di ‘affamato’ o ‘assetato’ la parola assume sfumature nuove: ad es. in contesti astratti vale ‘gretto, povero, limitato’, con implicazioni etiche o intellettuali (animus ieiunus, mens ieiuna). Con ulteriore estensione della metafora, ieiunus entra in un diverso linguaggio settoriale, quello dell’oratoria, dove espressioni come oratio ieiuna o orator ieiunus indicano il carattere disadorno di un testo o di un oratore.
LATINO: VARIETA’ DIACRONICHE
Nuova Secondaria, 15 aprile 1993, pag. 67 La tesi di Bonfante, citata nella precedente nota, secondo cui già nell’età imperiale si sarebbe parlata una lingua con molti dei tratti che caratterizzano l’italiano, non ha trovato concordi gli studiosi. Quando si è cominciato a parlare italiano, quando si è cessato di parlare latino? Quando, in una parola, è morto il latino? Domande non semplici, a cui è impossibile dare risposte precise, e che hanno visto diverse soluzioni a seconda degli elementi che si sono presi in considerazione o privilegiati: e in sostanza domande irrilevanti: ponendo l’accento più sulla continuità che sulla frattura, si potrebbe rispondere che mai si è cessato di parlare latino, perché le attuali lingue romanze non sono altro che la forma assunta dal latino parlato nel nostro tempo e nei vari paesi, senza che vi sia stata mai un’interruzione nella vicenda linguistica. Allora la domanda da porre è piuttosto un’altra: quando il latino scritto e il latino parlato hanno cessato di essere due varietà di un medesimo sistema linguistico? Sarebbe vano tentare una risposta fondandosi solo sui fatti linguistici: il problema va posto innanzitutto su basi culturali: la decadenza, e la successiva morte, del latino procede parallelamente al trapasso dalla civiltà antica verso la civiltà medievale, con un’evoluzione graduale, più veloce in certi secoli, più lenta in altri. A fronte di una relativa conservatività della lingua scritta sta il rapido e continuo irrompere di parole e costruzioni nuove nella lingua parlata: col passare dei secoli, la distanza fra le due varietà si accresce, nonostante che a partire dal V secolo il disgregarsi dell’unità politica (e quindi il cessare della funzione unificatrice, anche dal punto di vista linguistico, di Roma) e la minor attrattiva che esercitano i classici pagani consentano anche alla lingua scritta di adeguarsi almeno in parte all’evoluzione della lingua parlata, assimilandone le novità. Col divaricarsi della forbice, nel momento in cui le due varietà divengono due sistemi nettamente differenziati, non solo cessa ogni possibilità di naturale dialettica da parte della lingua scritta sulla parlata e viceversa, ma, poco o tanto, lingua scritta e parlata divengono reciprocamente incomprensibili, se non si ha una specifica preparazione (1). (1) Così come oggi una persona greca di media cultura non è in grado di leggere una pagina di Lisia o Demostene, benché la lingua che egli parla e quella dell’autore classico si chiamino entrambe greco: nonostante la continuità dell’evoluzione, lingua antica, lingua moderna scritta e lingua popolare reappresentano ormai realtà fortemente differenziate, vasi incomunicanti fra loro, se non si ha una preparazione specifica. |
Nuova Secondaria, 15 aprile 1993, pag. 67
Quello del latino medievale è un caso singolare. L. Bieler lo definisce “una lingua senza popolo”, rilevando l’unicità di questa caratteristica: “Le lingue del mondo, sia antiche sia moderne, sono per definizione parlate e capite da numerosi individui che non le hanno come lingue madri: ma esse, altrettanto per definizione, sono anche le lingue parlate di determinati popoli” (1). Il latino medievale non pare adattarsi alla definizione né di lingua viva né di lingua morta: “la lingua di una tradizione” la chiama R. Meister: “né una lingua nazionale né una lingua universale. […] Non è esclusivamente lingua della Chiesa, né la lingua di una classe. E’ una lingua senza comunità linguistica, e tuttavia non una lingua morta. Il latino medievale è la lingua di una comunione di idee” (2).
Quest’impostazione del problema è suggestiva. Che il latino medievale non sia da considerare una lingua morta è provato da molte considerazioni. E’ vero che nel Medioevo non ha parlanti nativi: ma, pur appresa nella scuola, è una lingua largamente praticata in numerosi ambiti sociali: le modalità di apprendimento del latino nel Medioevo e la sua diffusione non sono granché dissimili da quelle dell’italiano del Sette-Ottocento, definito polemicamente e provocatoriamente “lingua morta” da Carlo Gozzi e Foscolo (3). Il carattere di lingua viva del latino medievale è riconoscibile non tanto o non soltanto, come è stato detto, dalla presenza di componimenti poetici, perché l’ispirazione poetica può rendere vivo qualunque materiale (i componimenti latini di Pascoli sono poesia vera, e ciò non toglie che a quell’epoca il latino sia una lingua morta). Più che dall’esistenza di componimenti poetici, la vitalità della lingua è mostrata dalla sua capacità di dar vita e adattarsi a ritmi e regole prosodiche nuove, differenti da quelle della poesia classica legate a condizioni di pronunzia ormai desuete (si pensi agli esametri rimati del Ruodlieb). Ancora, a rendere vivo il latino medievale è la varietà delle sue espressioni: una lingua rimane viva finché esiste una interazione fra la norma (la “langue”) e il suo concreto attuarsi nella “parole” e, nel medesimo tempo, finché la “langue” può essere plasmata secondo le esigenze espressive degli autori. Tutto questo è vero per il latino medievale: la gamma delle varietà in cui la lingua si modella è pari al numero degli autori che la usano. La prosa, più o meno corretta a seconda della cultura dei vari autori, si rifà ai modelli latini tardi, sottolineando così la continuità di questa lingua rispetto al passato da cui muove i suoi passi.
La definizione del latino medievale come “lingua senza popolo” lascia perplessi, e sottende un’idea sostanzialmente romantica e inattuale di popolo. Il latino medievale è la lingua del popolo cristiano dell’Europa occidentale e centrale, che nell’uso di esso trova lo strumento per cementare un’unità culturale in via di formazione che trascende la diversità delle vicende etnico-culturali e linguistiche anteriori all’incontro di popoli latini, celtici, germanici, slavi, ugro-finnici e altro ancora. E’ vero che il latino non fu solo la lingua della Chiesa, ma è anche vero che la Chiesa cattolica si servì del latino come di un patrimonio proprio ed esclusivo, così che, come ha mostrato in un bel volume V. Coletti, l’equazione volgare = (potenzialmente) eretico venne a lungo accredita: non era possibile un insegnamento dottrinale alternativo a quello della Chiesa cattolica se non in una lingua diversa dal latino: patrimonio culturale latino e ortodossia cattolica costituivano un binomio indissolubile (4).
Perché e come il latino divenne una lingua morta? Morì di morte naturale o fu ucciso? L’una cosa e l’altra, scrive M. Van Uytfange (5). L’ abbandono del latino è sintomo insieme di una crisi e di un consolidamento: la crisi di un modello culturale che faceva del Cristianesimo il perno di ogni momento della vita, e il consolidamento di una unità culturale ormai sufficientemente solida per permettersi di esprimersi in lingue, la cui struttura mostravano comunque ampiamente un lungo sforzo di adeguamento ai modelli latini. Nel momento in cui l’occhio e il cuore sono rivolti non più a Cristo, bensì ai valori pagani, il latino medievale viene giudicato barbarie: paradossalmente, lo sforzo degli umanisti di ripristinare lo stile ciceroniano suona come una condanna a morte del latino: in luogo del fluire incessante e vario della vita, la rigidità del cadavere: l’uso del latino riformato potrà proseguire in determinati ambiti scientifici anche per secoli (si trovano opere di linguistica o matematica scritte in latino ancora nel secolo XIX), ma si tratta di una lingua ormai convenzionale, il cui carattere stanco e artificioso appare immediatamente. egli parla e quella dell’autore classico si chiamino entrambe greco: nonostante la continuità dell’evoluzione, lingua antica, lingua moderna scritta e lingua popolare rappresentano ormai realtà fortemente differenziate, vasi incomunicanti fra loro, se non si ha una preparazione specifica.
(1) L. Bieler, Das Mittellatein als Sprachproblem, “Lexis” vol. 2 (1949), pag. 98-104.
(2) R. Meister, Latein als Traditionssprache, in Liber Floridus, Festschrift Paul Lehmann, 1950.
(3) Sulla questione cfr. T. De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, Roma-Bari 19842, in particolare i capitoli primo e secondo.
(4) Cfr. V. Coletti, Parole dal Pulpito, Casale Monferrato 1986.
(5) M. Van Uytfange, Après les “morts” successives du latin: quelques réflexions sur son avenir, in Hommages à Jozef Veremans, Bruxelles 1986, pag. 328-354.
Nuova Secondaria, 15 gennaio 1995, pag. 56-57
Dopo cinque anni di insegnamento liceale, lo studente potrebbe non aver mai sentito nominare Paolo Diacono: si ricorderà del suo nome al massimo qualche studente particolarmente attento, per l’uso che ne fa, come fonte storica per l’Adelchi, Manzoni. Eppure i motivi che consiglierebbero di dare a Paolo Diacono almeno un minimo di spazio sono più di uno.
Innanzitutto quest’autore si colloca in un’epoca di crepuscolo, nella quale lo sguardo è comunque ancora fisso ai grandi valori del passato. Paolo Diacono è un nobile longobardo: ma la contrapposizione fra germanico e latino non è vissuta in lui come una contraddizione: fra mondo romano e mondo longobardo vi è coesione, non rottura, e il periodo longobardo è percepito come il prolungamento di quello romano, al punto da riscrivere Eutropio portando il racconto dei fatti fino alla sua epoca. Ha appreso il latino nella scuola, e lo usa come fosse la sua prima lingua, spingendosi fino a riassumere una delle più erudite e complesse opere di lessicografia dell’antichità, il De verborum significatione di Pompeo Festo. Non per questo viene meno in lui l’orgoglio dell’appartenenza alla gente longobarda: semplicemente, l’essere e il parlare longobardo sono il particolare, mentre il pensiero e la lingua di Roma offrono un respiro universale.
La sua Historia Langobardorum (1) è un documento molto interessante di prosa latina tarda: se paragonata ad altri documenti coevi di minore impegno, risalta la sua grande pulizia formale. Questo non elimina la presenza, rispetto alla morfologia e alla sintassi ciceroniana, di discordanze, che spesso documentano non tanto la negligenza di copisti che avrebbero travisato e involgarito il dettato dell’autore, quanto il carattere vivo di una lingua che, pur assumendo i grandi modelli del passato come punto di riferimento costante per un’espressione piena e articolata del pensiero, non rifiuta di adeguarsi alla rapida evoluzione del parlato. In Paolo Diacono l’adeguamento è comunque moderato, e, laddove forme del latino classico sono completamente uscite dall’uso, si ricorre per sostituirle non già alla forma volgare corrente, bensì a un’altra forma classica: ad esempio, in luogo dell’ormai debole ire, le cui forme monosillabiche sono all’epoca desuete, non si usano generalmente i volgari ambulare e vadere, bensì pergere; in luogo del disusato edere non si usa comedere (prevalente nella latinità iberica) o manducare (prevalente in Gallia e in Italia), bensì vesci. Si legga la presentazione di Liutprando (VI 58), per avere un’idea della sua prosa:
Fuit autem vir multae sapientiae, consilio sagax, pius admodum et pacis amator, belli praepotens, delinquentibus clemens, castus, pudicus, orator pervigil, elemosinis largus, litterarum quidem ignarus, sed philosophis aequandus, nutritor gentis, legum augmentator.
L’ossatura del periodo, con parallelismi, chiasmi, eleganti variazioni, la scelta dei vocaboli, tutto il modo di procedere insomma denuncia evidente il richiamo ai modelli classici: ma gli elementi caratteristici della latinità tarda si presentano in modo prepotente: un grecismo come elemosinis (nel latino tardo l’influsso greco è assai più forte che nella lingua classica), nomi in –tor (formazione particolarmente amata dal latino tardo) come amator e soprattutto nutritor, augmentator, o ancora un termine come pervigil, che la prosa postclassica (a partire da Apuleio) accoglie dalla poesia. Ma l’ossatura fondamentale della lingua è quella classica. Secondo L.J.Engels, che ha operato uno spoglio minuto del lessico di Paolo Diacono, gli elementi comunque classificabili come tardi costituiscono appena il 12,6% del totale, ed è significativo, in questo storico di madre lingua germanica, che mentre i grecismi hanno un discreto rilievo, i germanismi (limitati comunque a termini tecnici insostituibili) sono presenti nella proporzione di appena lo 0,6%. La conclusione è che “il latino di Paolo Diacono è il latino letterario. Non è una lingua artificiale («Kunstsprache»). Contiene un elemento artificiale: il mantenimento delle regole classiche, trasmesse dalla scuola; ma vi si aggiunge un elemento vivo, vale a dire l’applicazione di queste regole antiche ai materiali linguistici dell’epoca”. Le porte verso il nuovo sono aperte: ma il manifestarsi completo del nuovo non può avvenire che attraverso un’equilibrata valorizzazione dell’antico.
(1) Vi sono attualmente a disposizione almeno tre edizioni con testo e traduzione a fronte, tuute facilmente accessibili e affidabili: quella di Lidia Capo nella Collezione Valla (ed. Mondadori) e quelle economiche nella TEA (cur. E. Bartolini) e nella BUR (trad. e note di A.Zanella, introd. di B.Luiselli).
Nuova Secondaria, 15 aprile 1995, pag. 66
Non usa più, nei manuali attualmente in circolazione, dividere lo svolgimento della letteratura latina in età dai colori via via più spenti e di materiale sempre meno pregiato (aurea, argentea, bronzea, ferrea), che suggeriscono, se non un minor vigore dello spirito umano in determinate epoche, quanto meno una minore propensione a dedicarsi agli studi letterari quando contingenti situazioni storiche e culturali portano a coltivare attività diverse dalla letteratura e dal pensiero. Ma anche se la classificazione tradizionale è stata abbandonata, ne rimangono, quanto meno nell’inconscio collettivo, le tracce: alcune epoche sono considerate senz’altro superiori ad altre (e non è un giudizio basato sulla produttività, che sarebbe legittimato se non altro da ragioni statistiche, ma proprio sul valore): le epoche considerate meno nobili sono anche, per diretta conseguenza, meno degne di interesse e di studio. Chi ha esperienza di esami di maturità sa che, nelle classi terminali, difficilmente ci si può aspettare uno studio letterario che oltrepassi cronologicamente Tacito: in casi rari e fortunati si arriva fino ad Apuleio, che rimane nella gran maggioranza dei casi il limite estremo e invalicabile: in parte obiettive ragioni di tempo, in parte un giudizio sommario di condanna porta ad eliminare ciò che viene dopo: e poco importa che i secoli successivi annoverino personaggi come Ambrogio o Agostino. Occorre aggiungere che spesso anche l’insegnamento della filosofia è condotto in modo da arrivare al termine del primo anno alle scuole ellenistiche e da riprendere al secondo anno col Rinascimento: il risultato è che, mentre lo studio della storia fa emergere una continuità ininterrotta, lo studio della cultura letteraria e del pensiero presentano uno iato lungo un millennio, e proprio quel millennio che determina la storia e la cultura dell’Europa odierna.
A fare le spese di questo è in particolar modo la poesia. L’ approccio ai prosatori è consentito anche per vie diverse da quelle dell'”ora di letteratura”: attraverso le versioni o le verifiche linguistiche, per esempio. Inoltre la poesia è sottoposta ad un’azione di censura più radicale: alla prosa si riconosce quanto meno l’interesse di una testimonianza culturale che consiglia l’esame dei testi: per la poesia un argomento del genere non sarebbe valido: non per nulla mostrano maggior resistenza quei testi di poesia che per contenuto e stile si avvicinano maggiormente alla prosa e quindi vengono letti non in grazia del loro valore poetico bensì per motivi schiettamente contenutistici (è il caso di Persio e Giovenale, per fare dei nomi). Come conseguenza di tutto questo, chi esce dal liceo ha l’impressione che fra l’età augustea e la scuola siciliana non vi sia alcun testo poetico degno di lettura. La fragilità di una simile impostazione balza agli occhi. Non vorremmo però nemmeno che si arrivasse a un capovolgimento della situazione, con un appiattimento che costituirebbe l’esatto opposto di una svalutazione generalizzata e irragionevole e darebbe adito ad un errore esattamente antitetico al precedente, ma altrettanto grave. Altro è Virgilio, altro è Silio Italico: nessuna persona dotata di buon senso penserebbe di sostituire il primo col secondo. Vorremmo solo che alla poesia della latinità imperiale, tarda e medievale venisse accordata un’attenzione almeno pari a quella di cui godono tanti minori o minimi della letteratura italiana, che pure trovano spazio nell’insegnamento letterario.
Poiché conosciamo i condizionamenti e le limitazioni a cui è soggetto lo studio della letteratura nel triennio, suggeriremo qui una traccia di lavoro facilmente percorribile che utilizza strumenti molto semplici e di facile reperimento.
La Collezione di poesia dell’editore Einaudi contiene una breve antologia, curata da Carlo Carena, intitolata Poeti latini della decadenza (Torino 1988): gli autori compresi vanno dal secondo secolo (e precisamente dall’età di Adriano: i poëtae novelli si propongono come momento di rottura di una continuità culturale) fino al quinto: l’ultimo autore rappresentato è Draconzio, con cui “si può ben chiudere il capitolo della poesia latina pagana e interrompere il suo crepuscolo” (pag. XVI). In quasi ideale continuità con questa breve antologia si può considerare la recente raccolta Poesia latina medievale, curata da Gianna Gardenal (con la collaborazione di studiosi illustri) ed uscita nella collana Oscar Mondadori classici (Milano 1993). Gli autori raccolti spaziano da Paolo Diacono (VIII secolo) fino a Jacopone da Todi (morto nel 1306): giungiamo così fino a un periodo in cui il sopravvento della poesia in volgare è ormai solidamente affermato, e lo studio della letteratura latina si salda con lo studio della letteratura italiana. Entrambi i testi si prestano in modo favorevole a un’utilizzazione didattica: la scelta privilegia in entrambi passi brevi e di senso compiuto, le traduzioni a fronte hanno una loro densità letteraria che ne rende più gradevole la lettura e in entrambi si trova quell’insieme di notizie introduttive e di note che agevolano l’affronto del testo senza eccessivi appesantimenti. Il carattere delle due antologie rende possibile l’individuazione di alcune piste di lettura che, una volta presentate attraverso una breve esemplificazione, si potranno poi affidare agli allievi per un completamento e un eventuale approfondimento nella lettura domestica. Esamineremo in prossimi interventi alcuni di questi possibili percorsi.
Nuova Secondaria, 15 marzo 2002, pag. 66
Una pista di lettura facile da seguire e immediatamente produttiva, per chi utilizza l’antologia di poeti latini della decadenza che abbiamo nominato nel nostro precedente intervento (1), è quella che rileva il tenace attaccamento a Roma da parte dei letterati dell’età imperiale, letterati che, lo si tenga sempre nella dovuta considerazione, sono per la maggior parte cresciuti e vissuti alla periferia dell’impero. Si legga ad esempio nel brano di Claudio Claudiano riportato nell’antologia e tratto dal De consulatu Stilichonis, il lungo elogio di Roma (2). La lettura è tanto più impressionante, se si tien conto del fatto che queste parole furono scritte l’anno 400, quando la potenza politica di Roma doveva essere poco più di un ricordo e lo stesso impero d’occidente si avviava rapidamente e inesorabilmente a una fine non indolore. Ma non è tanto il giudizio politico ad animare la voce del poeta (ché altrimenti le sue parole suonerebbero vuote e retoriche: e le si possono mettere a confronto con le pagine del De civitate dei agostiniano, ove la consapevolezza della caducità dell’opera umana conferisce ben altro taglio e ben altro peso alla considerazione in chiave politica e teologica degli avvenimenti contemporanei): Claudiano afferma piuttosto con orgoglio la piena e compiuta realizzazione di un progetto di natura culturale che ha portato all’affermazione di una civiltà: “Haec est in gremium victos quae sola recepit | humanumque genus communi nomine fovit, | matris, non dominae ritu, civesque vocavit | quos domuit nexuque pio longinqua revinxit”. Ancora più marcata l’esaltazione di questa opera unificatrice nel noto passo del De reditu suo di Rutilio Namaziano, anch’esso riportato nell’antologia (3): qui l’affermazione è ancor più significativa, perché dall’insieme del poemetto aleggia una sensazione di squallore e di desolazione, soprattutto negli insistiti accenni a illustri città ormai abbandonate e a luoghi abbandonati e malsani. Non è neppure da sottovalutare il limite di questo atteggiamento: un tenace attaccamento ai riti del paganesimo ormai moribondo (si veda in Rutilio la nostalgica descrizione degli antichi riti in onore di Osiride), e il rifiuto pieno di livore di culture diverse da quella romana, come appare dalla violenta e sgradevole invettiva di Rutilio contro i giudei. Da un punto di vista letterario questo atteggiamento si esprime con la ripresa di tematiche mitologiche ormai lontane dalla sensibilità comune, con la conseguente creazione di poemetti di fattura accurata, ma sostanzialmente vuoti di contenuto e di afflato poetico. In sostanza, il tono poetico è stanco e ripetitivo quando l’autore si cimenta con tematiche di natura epica, sia nella forma più ampia del poema sia nel componimento più breve dell’epillio: lo si rileverà, facendo sempre riferimento a brani contenuti nell’antologia citata, sia dai passi del De raptu Proserpinae di Claudiano (4) sia da altri componimenti di minor valore e notorietà come il Concubitus Martis et Veneris di Reposiano (5): si potranno trovare qua e là occasionalmente dei momenti di vera poesia (si veda nel De raptu Proserpinae la descrizione dell’alba sul mare [6]), ma si tratta di evenienze tutto sommato rare.
Diverso il discorso quando si ha a che fare con componimenti di minor impegno o di natura personale: per limitarci a un solo esempio, meriterebbe considerazione la Mosella di Ausonio: accanto a qualche lungaggine e a qualche eccessiva enfasi, si hanno momenti di sincera commozione, e il preziosismo linguistico rende la descrizione efficace e nitida, dando adito anche a soluzioni stilistiche ed espressive sicuramente interessanti: ma soprattutto, vi si sentono gli echi di una civiltà in profonda trasformazione. Cristiano, sia pure convertito in tarda età e forse mai fervente, fu Ausonio, così come fu cristiano (e vescovo di Arvernia) un altro degli autori menzionati nell’antologia, Sidonio Apollinare: potrebbe essere interessante notare come la poesia cristiana si avvalse di moduli stilistici nati nella tradizione pagana per esprimere contenuti nuovi: il materiale offerto dall’antologia è però troppo limitato per affrontare un tema del genere, la cui importanza risulta peraltro evidente, e che sarà bene rinviare ad altra occasione.
(1) Poeti latini della decadenza a cura di Carlo Carena, Torino, Einaudi 1988
(2) Op. cit., pag. 96-99 (si tratta dei vv. 130 e ss. del poemetto).
(3) Pag. 114-115.
(4) Per un ulteriore approfondimento l’allievo ha a disposizione una comoda edizione, con traduzione a fronte, del De raptu Proserpinae di Claudiano (a cura di F. Serpa, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1981).
(5) L’antologia offre una cinquantina di versi di questo poemetto (sui 182 complessivi): si potrebbe mettere a confronto la grazia un po’esangue e leziosa della descrizione col proemio del De rerum natura lucreziano, ove la tematica degli amori di Marte e Venere, comunque convenzionale e non priva di leziosità, è piegata a una problematica ben diversa, ovvero, per chi ha la possibilità di accedere direttamente al testo greco, con la fonte ultima del passo nell’Odissea (VIII 266 ss.), ove si troveranno ben diversa sobrietà e capacità evocativa nella dichiarata ironia della descrizione.
(6) Si tratta dei versi II 1-3, pag. 108-109 dell’antologia.
Nuova Secondaria, 15 aprile 2002, pag. 60
Anche il secondo degli strumenti indicati nei nostri precedenti interventi (1) si presta ad essere affrontato secondo il taglio già enunciato. Balza immediatamente agli occhi, appena si apre il volume, la presenza di svariati nomi di origine germanica e di personaggi provenienti dal nord, fino dall’Irlanda e dalla Scozia. Con la caduta dell’impero romano, il baricentro si è spostato da Roma e dal mediterraneo verso l’Europa centro-settentrionale: è in circostanze del genere che si avverte come la nascita dell’Europa moderna affondi le sue radici nella cultura classica, a cui il Cristianesimo ha aggiunto nuova linfa di vitalità e di contenuti. Cambia il paesaggio: prevalgono i freddi nordici, e il rigore dell’inverno è descritto vivacemente nel contrasto di Alcuino (pag. 15) e percepito in tutta la sua durezza da Valafrido Strabone, che così si lamenta nel suo canto d’esilio: “Frigus invasit grave nuditatem, | non calent palmae, pedibus retracta | stat cutis, vultus hiemem pavescit | valde severam. | In domo frigus patior nivale, | non iuvat cerni gelidum cubile, | nec foris lectove calens repertam | prendo quietem” (pag. 50, vv. 13-20). Cambiano i gusti: per placare la sete non c’è più solo il vino, ma compare anche la birra leggera (cacavis), di sapore sgradevole e apportatrice di malinconia (“crudelis bestia … nec gustu facilis, nulli potabilis ipsa … laetitiam removet tristitiamque gerit“: Sedulio Scoto, pag. 62) Cambiano i personaggi: non sono più le figure dei miti ad essere protagoniste, bensì Sant’Orsola o la Vergine Maria, e l’argomento dei carmi trae spunto da episodi biblici (p. es. pag. 152, il lamento di Israele per Sansone scritto da Abelardo). Cambiano le forme metriche: accanto agli esametri, ai distici elegiaci, ad altri metri della tradizione classica si trovano forme completamente nuove, versi rimati, sequenze intervallate da ritornelli.
Ma, al di là di questo, si avverte ben preciso il senso di una continuità: la fede cristiana non impedisce, ad esempio, di richiamare le figure della mitologia pagana, o di attribuire al Dio cristiano o a Cristo stesso epiteti precedentemente attribuiti a Giove (“Christi pietas tonantis” in Valafrido Strabone, pag. 54): un esempio cospicuo di questo tendenziale sincretismo culturale, che non mette comunque mai in dubbio l’adesione al messaggio cristiano, si può leggere nel breve componimento anonimo tratto dai Carmina Cantabrigensia (riportato a pag. 106), in cui il destinatario del brano (pederotico!) è paragonato a Venere, e sul suo viaggio è invocata la protezione delle Parche, di Nettuno e di Teti, oltreché, beninteso, quella di Dio (“archos te protegat, qui stellas et polum | fecit et maria condidit et solum“).
Ma pur nella ricchezza di contenuti nuovi, sono le forme e le modalità espressive precedentemente elaborate dal mondo romano a farsi continuamente sentire. Alcuino di York lamenta che si sia allontanato dalla sua scuola un giovane discepolo, chiamato “il cuculo”: i Versus de cuculo (pag. 12-15) hanno la forma dell’ecloga virgiliana, e al giovane stesso viene conferito il nome convenzionale di Dafni; non diverso è l’atteggiamento del carme in cui Primavera e Inverno espongono alternativamente i loro pregi in un dialogo esametrico nel quale ogni battuta dei due dialoganti consta di tre versi (“adlusit terno modulamine versus“): convenzionale la scena dei pastori, che a primavera scendono dai monti per celebrare il cuculo, convenzionali i nomi dei due pastori (il giovane Dafni e l’anziano Palemone), mentre nella chiusa, col vibrato invito al cuculo perché ritorni, riecheggia trasfigurato il motivo già menzionato nel carme precedente.
Proporre la lettura di questi brani non è solamente un obbligo che discende da un elementare senso di giustizia nei confronti di un’epoca ingiustamente censurata. Si suole parlare di decadenza (ed è termine del tutto improprio se applicato alla letteratura) o quanto meno di transizione, dando a questo termine una valenza negativa (qualcosa di mediocre fra un positivo precedente e un positivo successivo). In realtà si dovrebbe parlare di continuità. Proporre questi testi (con ovvio senso della misura e sempre pronti a valutare obiettivamente e serenamente il diverso valore poetico dei vari brani) significa allargare l’orizzonte culturale dei ragazzi, mostrare come un tenue filo, comunque mai interrotto, colleghi l’esperienza letteraria antica con la nostra, così che lo stesso mutare degli scenari storici e linguistici costituisce non il dato primario, bensì un evento tutto sommato contingente e accidentale all’interno di un prolungarsi ininterrotto di motivi poetici e di modalità espressive che, in una cangiante varietà e in un continuo ricrearsi e riflettersi, collegano l’antica Roma (e, più a monte, la Grecia, che dell’esperienza romana fu modello e ispiratrice) alla nostra cultura europea ed occidentale.
(1) Poesia latina medievale, a cura di Gianna Gardenal, Milano, Mondadori (Collana Oscar Classici), 1993.
LATINO: VARIETA’ DIATOPICHE
Nuova Secondaria, 15 ottobre 1998, pag. 74-75
Nell’insegnamento del latino aspetti linguistici e culturali sono correlati: non è possibile un insegnamento della lingua che prescinda dall’aspetto culturale né un insegnamento della civiltà romana che trascuri l’importanza della lingua; se il primo sarebbe sterile, il secondo sarebbe monco, se non altro perché la lingua è essa stessa parte integrante di una cultura e veicolo essenziale del suo mondo di valori. Quanto l’affermazione di principio è ovvia, tanto il suo tradursi nella pratica presenta aspetti delicati: negli anni iniziali la lingua ha un peso predominante, col rischio di mettere troppo sullo sfondo l’aspetto culturale. Ma già all’inizio il momento dell’apprendimento lessicale permette di allargare la prospettiva avviando l’allievo a una prima percezione del mondo valoriale latino e richiamando a fatti storici e culturali di un certo spessore. La pista di lavoro che qui suggeriamo, oltre a dare del mondo romano un’immagine un po’ diversa da quella di molti manuali di storia, consente anche un lavoro interdisciplinare tra latino e lingua straniera.
Il prestigio della cultura latina ha favorito una penetrazione di usi e pratiche romani in vasti territori dell’Europa, dell’Africa e dell’Asia che non furono mai assoggettati dalle armi di Roma. Poiché l’importazione di un oggetto o di una moda straniera reca generalmente con sé anche l’importazione del relativo significante, si assiste a una irradiazione di parole latine in tradizioni linguistiche anche lontane. In precedenti contributi apparsi su “Nuova secondaria” (settembre 1993 e giugno 1994) ho già avuto occasione di richiamare il ruolo avuto dalle lingue classiche (non solo dal latino, quindi) nel favorire la progressiva convergenza, tuttora in atto, di molte lingue europee. Tale processo fu indubbiamente accelerato da quell’incontro-scontro di culture che si attuò dopo la fine dell’impero e che portò alla formazione dei regni romano-barbarici, ma il suo inizio va collocato in epoca assai anteriore alla dissoluzione dell’impero. L’intensificarsi dei commerci ebbe notevole rilievo nell’annodarsi di relazioni sempre più strette fra Latini e Germani. Se la cultura ufficiale ebbe nei confronti del mondo germanico un atteggiamento ambivalente (il complesso di superiorità di chi riconosce il proprio tenore di vita più elevato, e il complesso d’inferiorità di chi è convinto che lo stile di vita più austero pone i Germani al riparo da quelle debolezze e da quella corruzione che sembrano fatalmente il portato di una cultura superiore), i mercanti favorirono in modo diretto e dinamico il contatto tra le due culture. La storiografia ufficiale guarda con un disprezzo non dissimulato l’attività del commercio: Cesare (B.G. IV 2) e Tacito (Germania 5) ne minimizzano l’importanza, e ne mettono in rilievo il carattere unilaterale (i Germani vendono i propri prodotti, ma sono restii a introdurre merci straniere); i dati archeologici per contro accennano a scambi di una certa consistenza, perché si sono trovate quantità notevoli di monete romane in territori dell’Europa centro-orientale anticamente abitati da tribù germaniche (nella zona della Vistola o nella Bielorussia, per esempio). Un episodio narrato da Tacito (Annales II 62) mostra come i mercanti romani non avessero timore di inoltrarsi ben addentro ai territori barbarici: nel 19 d.C. un nobile goto di nome Catualda alla testa di un esercito invade il territorio dei Marcomanni, nell’odierna Boemia, e nella loro capitale trova numerosi mercanti romani che l’ingordigia e un colpevole oblio delle proprie radici aveva spinto nel cuore di una terra nemica (lixae ac negotiatores … quos ius commercii, dein cupido augendi pecuniam, postremo oblivio patriae suis quemque ab sedibus hostilem in agrum transtulerunt).
L’importanza del commercio tra Latini e Germani si riflette sul piano linguistico. Le più antiche parole germaniche che designano il commercio sono prestiti dal latino: si tratta del verbo che troviamo nella traduzione gotica della Bibbia (sec. IV d.C.) nella forma kaupon e che ha assunto nelle lingue germaniche moderne, in seguito a regolari trapassi fonetici, la forma ted. kaufen, sved. köpa, ingl. to cheapen (in quest’ultima lingua col valore più ristretto di ‘abbassare il prezzo, svalutare’); in antico alto tedesco troviamo anche il sostantivo koufo ‘mercante’, che non è però continuato nella fase moderna della lingua. Si tratta di una derivazione del lat. caupo (o del suo derivato cauponari) nel suo duplice valore di ‘oste, albergatore’ e di ‘mercante’. Poiché la parola apparteneva a un registro non particolarmente elevato, appare chiaro che i primi termini latini sono approdati al germanico attraverso la viva voce dei parlanti, non attraverso i libri e la letteratura: è anche singolare che di caupo e derivati non sia rimasta traccia nel mondo romanzo. I Germani hanno poi fatto da tramite per l’ulteriore passaggio della parola ad altre lingue e culture: troviamo così riflessi della parola latina nel mondo slavo (p. es. russo kupit’ ‘comprare’, pol. kupiec ‘mercante’) e addirittura, al di fuori dell’ambito indeuropeo, nel lontano finnico (kouppo ‘vendere’); si presenta così davanti ai nostri occhi una rete di relazioni e di rapporti tra popoli e culture quanto mai complessa e inattesa.
Nuova Secondaria
Il più antico testo germanico che abbia una certa estensione è la traduzione della Bibbia in gotico (una lingua germanica orientale oggi estinta): di questa traduzione, compiuta nel sec. IV dal vescovo ariano Wulfila, ci sono pervenute parti abbastanza ampie, soprattutto del Nuovo Testamento. Non mancano testi cronologicamente anteriori (le iscrizioni runiche), ma la loro estensione è troppo limitata e il lessico che esse presentano ha un carattere troppo ripetitivo per avere interesse dal nostro punto di vista. Un primo elementare criterio per stabilire l’antichità dei prestiti latini nelle lingue germaniche è costituito dalla presenza del termine nella Bibbia di Wulfila o dalla sua estensione in tutte le lingue germaniche, indizio certo del fatto che esso è pervenuto in territorio germanico in un’epoca in cui la circolazione linguistica tra le varie tribù era ancora viva e vitale.
Tra i prestiti più antichi va annoverata la parola indicante il ‘vino’, che appare come wein in gotico, wīn in ant. tedesco (oggi Wein) e in ant. inglese (oggi wine), vín in ant. nordico. Senza entrare in particolari eccessivamente tecnici, che diminuirebbero l’interesse dell’allievo, ci limiteremo alla rilevazione di quattro aspetti culturalmente e linguisticamente interessanti.
1. I Germani importano dall’impero romano il vino, in quanto la coltivazione della vite è sconosciuta ai popoli dell’Europa centrale e settentrionale: più in generale possiamo dire che la vite è caratteristica del mondo mediterraneo, e l’uso del vino era ignoto all’ambiente linguistico e culturale degli Indeuropei primitivi, che usavano come bevanda inebriante l’idromele (gr. méthy, ted. Met, ecc.): la stessa parola lat. vínum e i suoi equivalenti in altre lingue, indeuropee e no (gr. oînos, arabo wain, ecc.) è ripresa da lingue di culture e civiltà che precedettero l’avvento degli Indeuropei nelle regioni meridionali dell’Europa.
2. Già nella Bibbia gotica troviamo numerose derivazioni dalla parola fondamentale, segno che la parola è ormai perfettamente integrata nel tessuto della lingua: è questo un ottimo indizio per definire l’antichità del prestito e la sua penetrazione nell’ambiente germanico: ad es. weina-gards ‘vigna’ (con gards ‘casa, cortile’), weina-triu ‘vite’ (con triu ‘albero’), wein-drugkja ‘ebbro’ (con un corradicale del verbo drigkan ‘bere’, l’equivalente gotico di ingl. drink e ted. trinken). Anche molti altri termini relativi alla coltivazione della vite o alla conservazione del vino sono attestati in lingue germaniche e vari elementi di natura storica, linguistica e culturale permettono di datare questi prestiti come precristiani: p.es. in gotico troviamo aket ‘aceto’ (e anche il ted. Essig è una deformazione della stessa parola latina), in tedesco Keller ‘cantina’ (dal lat. cellarium) o Kufe ‘tino’ (dalla forma lat. volgare cōpa) o Most ‘mosto’ (dal lat. mustum) o Winzer ‘vignaiolo’ (dal lat. vinitorem): potrebbe essere il tema di una ricerca, da farsi naturalmente con l’ausilio di un affidabile vocabolario etimologico.
3. Come già abbiamo visto, il mondo germanico fa da tramite per la diffusione della parola in altre culture: i termini per ‘vino’, ‘mosto’, ‘aceto’ e altri passano nel mondo slavo (in ant. slavo rispettivamente vino, mŭstŭ, očĭtŭ), e da qui eventualmente nel mondo baltico (lit. vynas ‘vino’).
4. Nelle lingue germaniche antiche la parola per vino appartiene al genere neutro, così come il termine latino da cui è mutuata. Nel tedesco moderno però troviamo Wein maschile. In realtà anche nella fase antica del tedesco troviamo tracce dell’appartenenza di wīn al genere neutro (rōt wīn ‘vino rosso’, hwīz wīn ‘vino bianco’). Il cambiamento di genere è dovuto a ragioni esterne. Nel latino parlato il neutro è andato rapidamente decadendo, tanto da lasciare nelle lingue romanze pochissime tracce della sua antica esistenza. In particolare nella parola per ‘vino’ il passaggio al maschile risale quanto meno ai primi secoli dell’impero: troviamo vinus già nel romanzo di Petronio. Il passaggio della parola tedesca dal neutro al maschile mostra dunque come siano stati duraturi i rapporti e gli scambi linguistici tra mondo latino e germanico, tanto da favorire un passaggio di genere che non sarebbe giustificato in tedesco, dove il genere neutro ha continuato ad esistere fino ad oggi.
Nuova Secondaria
Come accennato nei precedenti interventi, le parole latine della Bibbia gotica possono dare informazioni interessanti su quegli aspetti della vita romana che una popolazione barbarica percepiva come caratteristici. Si ricordi che l’uso della parola straniera dipende, il più delle volte, dal riconoscimento di una lacuna nel proprio sistema lessicale: il parlante ricorre al prestito quando avverte di non possedere nel proprio sistema lessicale lessemi adeguati per esprimere un determinato concetto. Si è visto che i termini relativi al vino e in genere alla coltivazione della vite sono d’importazione latina. Anche per designare l’asino, animale tipico dell’ambiente mediterraneo, e pertanto anticamente sconosciuto ai Germani, si dovette ricorrere a un prestito dal latino, e poiché nel parlato il diminutivo era molto usato, tanto da prevalere spesso sulla stessa forma fondamentale della parola, la base dei prestiti germanici è la forma asellus, non asinus: la parola appare in gotico come asilus (e nel tedesco moderno come Esel); nella forma slava (osĭlŭ) e baltica (lituano asilas) si ha, come spesso, l’ulteriore espansione verso l’Europa orientale della parola latina passata attraverso il tramite germanico.
Prescindiamo qui dai termini tecnici relativi alla religione e al culto cristiano, e ci soffermeremo su alcune parole che presumibilmente sono entrate in ambiente germanico prima dell’evangelizzazione cristiana. Può essere dovuta ai Romani la diffusione di recipienti di metallo: troviamo in gotico katils (e in tedesco Kessel), dal lat. catillus, diminutivo di catinus: un oggetto che i Germani contribuirono a far conoscere ad altre civiltà dell’Europa orientale e settentrionale, a quanto è dato ricavare dallo slavo kotĭlŭ, dal lituano katilas, dal finnico kattila. Un gruppo di parole che i Goti riprendono dal latino sono quelli relativi alla cura del corpo e della persona: paurpura ‘porpora’ (col verbo che ne deriva, paurpuron ‘colorare di porpora’), balsan ‘unguento’ (dal lat. balsamum), kapillon ‘radersi’. In modo particolare sono numerosi i termini relativi alla tavola e al cibo, dalle stesse parole che indicano la mensa (got. mes, da lat. mensa, che nella lingua parlata era pronunziata correntemente mesa) e il porsi a tavola (got. anakumbjan, da lat. accumbere): evidentemente l’abitudine romana di prolungati e sontuosi banchetti non lasciava indifferenti le popolazioni germaniche. Romano è l’uso del tovagliolo, in gotico aurali (alterazione del lat. orarium ‘panno per detergersi la faccia, fazzoletto’). Il recipiente per il vino è detto in got. aurkeis, dal lat. urceus, e per bere si usava il calice (lat. calix: casualmente il termine non appare in gotico, ma un prestito sicuramente antico è presente in altre lingue germaniche, e sopravvive nel tedesco Kelch). Tra le componenti essenziali del banchetto è infine la lucerna (got. lukarn).
Poiché furono i mercanti romani a introdurre fra le tribù germaniche un metodo di rapporti commerciali non basato sul semplice baratto, non stupirà che siano di origine latina i termini che indicano il far di conto, le unità di misura e la moneta. Il got. raþio è la pura e semplice trascrizione del lat. ratio: dal sostantivo i Goti ricavano anche il verbo ga-raþjan ‘contare, numerare’; l’ampiezza semantica del termine latino è rispecchiata dalla sua ripresa germanica, in quanto rathjo è usato nel Nuovo Testamento per tradurre sia lógos ‘ragione, discorso’, sia arithmós ‘numero’; poiché il tedesco moderno Rede (che è la fedele continuazione della stessa parola germanica) significa ‘discorso’, si osserva che nella storia successiva del termine il primo valore è prevalso sul secondo. Got. pund, che traduce gr. lítra ‘libbra’, è dal lat. pondus: l’inglese pound e il tedesco Pfund sono le continuazioni moderne della stessa forma. Forme derivate dal latino moneta (divenuta, in bocca germanica, múnita, con una ritrazione dell’accento e cambiamenti del vocalismo coerenti con le tendenze generali della fonetica germanica) sono il mint dell’inglese e dello svedese nonché il Münze del tedesco moderno. E poiché sacchi e ceste erano strumenti indispensabili dei mercanti romani che s’inoltravano nel territorio germanico recando con sé i beni da vendere, è al latino saccus e cista che fanno riferimento da una parte il termine gotico sakkus, dall’altra un termine che, pur non testimoniato in gotico, si ritrova nel tedesco Kiste e nelle forme equivalenti delle altre lingue germaniche: si tratta di un prestito assunto dal germanico quando la c di cista davanti vocale palatale (e, i) era ancora pronunziata [k], diversamente da quanto appare nelle continuazioni italiana, spagnola, portoghese e così via: si tratta quindi un prestito che risale quanto meno ai primi secoli dell’impero.
Nuova Secondaria
Si è accennato finora al passaggio di termini germanici in latino. L’intensificarsi dei contatti tra le due culture, dopo la dissoluzione dell’impero e con la nascita dei regni romano-barbarici, portò anche all’ingresso di parole germaniche nel latino. Quest’influsso, assai meno sensibile nella lingua letteraria, che per motivi puristici era pur sempre riluttante ad accogliere parole straniere, fu molto più robusto nella lingua parlata, e se ne vedono gli effetti in modo particolare in quelle continuazioni del latino parlato che sono le lingue romanze. Poiché i nuovi programmi di storia hanno portano a una amputazione vigorosa, quanto storicamente ingiustificata, di questo delicato periodo, potrebbe essere utile cercare di recuperare qualcosa attraverso lo studio linguistico, ricordando che alla base del divenire linguistico vi sono spesso importanti ragioni di carattere culturale.
Qual è la ragione, ad esempio, che spinge i Latini a sostituire, in molti settori del lessico, una terminologia precedentemente esistente con elementi d’accatto? Nell’ambito della terminologia militare il motivo è evidente. Se in epoca precedente la superiore organizzazione della milizia romana aveva portato al passaggio di parole latine in gotico (p.es. spaikulatur da lat. speculator, il verbo militon da lat. militare), con la decadenza politico-militare romana si ha la tendenza inversa: antichi prestiti germanici sono, per esempio, guerra (che sostituisce bellum), truppa o schiera (che sostituiscono exercitus: l’italiano esercito è parola di origine colta), elmo, tregua. Provengono dal lessico militare anche parole come albergo (da un germanico hari-bergo ‘riparo per la truppa’), arengo e arringare (da hari-hrings, propriamente ‘cerchio dell’esercito’, che allude alla disposizione in circolo dell’esercito attorno a un oratore), gonfalone (da gund-fano ‘stendardo per la batta-glia’). L’interesse dei Romani per il diritto portò alla nascita di una terminologia rigorosa e fortemente articolata. Ma nel momento in cui la giustizia è amministrata da tribunali germanici sulla base di norme germaniche, si devono introdurre termini nuovi per indicare istituti diversi da quelli patri: tali ad esempio faida, fio, guidrigildo. Le forze dell’ordine sono costituite da guardie, oppure da scherani o sgherri, mentre un funzionario di rango più elevato è lo scalco. Se per molti oggetti e momenti del convivio i Germani ricorsero a parole latina, di origine germanica è la parola fiasco o fiasca.
In italiano vi è una triplice stratificazione di prestiti germanici, in relazione con le tre principali fasi della penetrazione germanica in Italia (gotica, longobarda, franca): argomenti di ordine linguistico, geografico e storico permettono in genere di stabilire, anche se non sempre in modo certissimo, la provenienza della parola: ad esempio banca è gotica, panca longobarda; balcone è gotico, palco longobardo. Ma il dato più interessante è che, a differenza di quanto avveniva negli imprestiti latini in germanico, la maggior parte delle parole che percorrono la strada inversa riguardano aspetti umili della realtà. Appartengono (o appartenevano) agli strati più bassi del lessico termini come rubare, arraffare, arrancare, astio, bega, buttare, guercio, gruccia, laido, melma, pozzanghera, sguattero, slittare, stalla, stamberga, e via dicendo. Ancora nella lingua attuale il trincare e il ghignare germanico hanno un valore ben diverso e meno nobile del bere o del ridere di origine latina. In qualche caso il valore anticamente basso della parola è più difficile da avvertire, perché l’evoluzione semantica l’ha sensibilmente allontanata dal significato originario: è il caso ad esempio di sala, che in origine indicava le dimore a un solo locale dei Germani, in quanto contrapposte alle abitazioni a più locali dei Latini. Quest’aspetto era stato fortemente rilevato da K. Gamillscheg, uno studioso che, trattando del problema in un’opera tuttora fondamentale, Romania Germanica (Berlino-Lipsia 1934-1936), scrive: «Negli imprestiti gotici in italiano si rispecchia tutta la miseria della popolazione straniera rimasta in Italia, che fino all’arrivo dei nuovi signori germanici, i Longobardi, condusse una vita da paria. (…) Quel che è rimasto di relitti lessicali longobardi nell’italiano proviene praticamente tutto da questo livello inferiore, dal patrimonio lessicale dell’“uomo-stamberga”, non del conte longobardo». Non è qui il caso né di approfondire né di valutare una simile problematica: rinviamo chi volesse avere ulteriori ragguagli al volume di G. Bonfante, Latini e Germani in Italia, Bologna, Pàtron, 1977 (ma sull’argomento sono disponibili moltissimi altri lavori). A noi basta rilevare come lo studio del lessico latino possa essere condotto secondo una prospettiva di interesse storico e culturale. Resta inteso (ma questo lo davamo per scontato) che il lavoro qui proposto non costituisce il fine né ultimo né principale dello studio del latino: è semplicemente un’occasione per aggiungere un motivo in più d’interesse nello studio della lingua.
Nuova Secondaria
La consistenza dell’eredità che le lingue classiche ci hanno trasmesso non può essere valutata solo sulla base del lessico. Certamente i vocaboli di derivazione latina costituiscono l’ossatura fondamentale del lessico delle lingue romanze, e in secoli più recenti una forte espansione di parole greche e latine, soprattutto nella terminologia tecnica e intellettuale, ha contribuito al formarsi di un lessico comune europeo (lo Standard Average European). Ma, pur senza sottovalutare questo aspetto, vi sono influssi di natura stilistica e sintattica che ancora meglio permettono di apprezzare il debito che le lingue dell’Europa moderna hanno nei confronti della cultura classica: e parliamo in questo caso di lingue dell’Europa moderna, e non solo di lingue romanze, perché l’imitazione di costrutti latini non riguarda solamente quegli idiomi che sono la diretta continuazione del latino parlato nell’impero romano, bensì quasi tutte le lingue europee che hanno alle spalle una tradizione letteraria, tanto indeuropee quanto, in alcuni casi, non indeuropee, come l’ungherese o il finnico. Un noto linguista, R. A. Hall, autore di una grammatica ungherese, scrisse che “l’ungherese differisce dalle lingue indeuropee dell’Europa occidentale moltissimo nella fonetica, parecchio nella morfologia, ma poco nella struttura della frase e della proposizione”. Chi legge un testo di prosa moderna scritto in una lingua europea diversa dall’italiano vi percepisce spesso, al di là delle naturali diversità linguistiche, qualcosa di familiare, che non si avverte leggendo pagine scritte in lingue che non sono state a contatto con la tradizione classica. C’è sullo sfondo un modo di pensare e di organizzare i pensieri per buona parte comune. Un grande grecista, E. Schwyzer, autore della grammatica storica tuttora fondamentale per chiunque operi nel campo della linguistica greca, scrisse che è più facile tradurre uno scritto in prosa (per esempio una lettera d’affari) dal tedesco in un’altra lingua europea o in latino che in un dialetto svizzero (o, aggiungiamo noi, italiano), perché, poco o tanto, i testi di prosa impegnata sono permeati dai modelli classici. Questa omogeneità non è un dato di fatto genetico: non rappresenta cioè la continuazione di uno stato di cose originario. Molte lingue (anche romanze) hanno trasformato la loro struttura, abbandonando costrutti precedentemente in uso, per accogliere strutture proprie delle sintassi latina (o greca). Diversi fattori contribuirono a questo esito: il prestigio assunto, in ogni contrada d’Europa, dagli autori classici, soprattutto nell’Umanesimo e nel Rinascimento, e il diffondersi di traduzioni dei classici: ogni traduzione, oltre a portare con sé il mondo di valori dell’autore, influenza in qualche misura lo stile della lingua d’arrivo: e l’idea che la traduzione dei classici potesse avere un effetto positivo sulle letterature moderne era diffusa (la tesi fu compiutamente esposta da Scipione Maffei in uno scritto del 1720). Era presente, conscia o inconscia, la sensazione che non si potesse scrivere della buona prosa se non seguendo il modello latino (di cui Cicerone era indiscutibilmente il massimo rappresentante). Quali sono le caratteristiche essenziali che definiscono questo modello? Senza entrare in particolari strettamente tecnici, e senza enumerare le costruzioni delle lingue europee moderne che ricerche solide e documentate fanno considerare imitazioni di costrutti latini, ci limiteremo a indicare un paio di tratti di fondo: la prevalenza di frasi ampie e strutturate, con abbondante uso della subordinazione, e la volontà di collegare fra loro sia i vari elementi del periodo, sia più periodi tra loro, rendendo trasparenti i nessi che uniscono i vari membri. La prevalenza dell’ipotassi distingue la lingua scritta dal parlato, in cui, come è naturale, la dinamica della comunicazione, le esigenze espressive, il minore rigore formale fanno prevalere una sintassi meno strutturata. In molte lingue (compreso l’italiano) la tendenza attuale parrebbe preferire la paratassi a scapito della subordinazione. Si tratta di un’apparenza. In realtà le congiunzioni, i pronomi e gli avverbi relativi, gli infiniti e i participi conservano una presenza sempre ragguardevole nei moderni testi scritti, e l’asindeto è tuttora percepito come marcato, tanto che se ne fa uso solamente per ottenere fini stilistici ben determinati. In ogni modo la propensione per la frase breve ha ragioni più letterarie che linguistiche: essa muove fondamentalmente dalla convinzione che lo scritto debba avvicinarsi al parlato, imitandone nella misura del possibile le movenze. Nello stile giornalistico la preferenza per la frase breve è motivata dal principio che il lettore è per sua natura frettoloso, non disponibile quindi a cimentarsi nella lettura di testi impegnativi. In realtà basta leggere le pagine dei quotidiani per accorgersi di come tutto ciò sia una petizione di principio più che una realtà. Persino nelle pagine delle cronache sportive si trovano periodi complessi e costruiti con precise corrispondenze dei vari membri. In molti casi la brevità della frase è fittizia e frutto di un artificio grafico, in quanto si pone un punto a metà di un periodo logicamente unitario e si riprende con una congiunzione subordinante, come appare dal seguente esempio, scelto a caso: «Ma ormai nel gruppo dei campioni d’Italia gli stranieri sono integrati, con o senza passaporto. Tanto che (introduce una consecutiva in dipendenza dal periodo precedente), in occasione del calcio di rigore che poi avrebbe fruttato la terza segnatura, Albertini ieri sera ha rinunciato a calciare nel rispetto dei desideri della curva, che invocava Bierhoff sul dischetto (dipendenza di IV grado)» (Corriere della sera, 26/9/99). È così naturale e spontaneo questo modo di organizzare il pensiero in periodi ampi, da rappresentare il DNA della prosa europea: per contro appare innaturale e forzato un modo di scrivere che procede per frasi giustapposte e prive di nessi. Anche gli insegnanti d’italiano dovrebbero tenere conto di questo dato di fatto storico, quando educano i loro allievi alla scrittura.
A una scrittura caratterizzata da periodi ampi con prevalenza di subordinate il latino approdò dopo un lungo periodo di elaborazione, e fu l’influsso della cultura greca ad agire in modo determinante. Anche in greco peraltro questo modo di scrivere non deve essere considerato originario. Il periodo complesso è un’innovazione dell’Atene periclea: le coordinate storiche e culturali hanno in questo caso strette relazioni con gli eventi linguistici. La prosa complessa nasce in un periodo in cui la lotta politica è vigorosa e ferve l’attività dei tribunali: quando è d’obbligo convincere avversari e interlocutori della superiorità delle proprie posizioni, il periodo complesso si pone come uno strumento efficace sia per conferire sintesi alle proprie idee sia per permettere all’interlocutore di seguire con chiarezza il dipanarsi dei concetti, indicandone le gerarchie e i nessi. Che si tratti di un’innovazione ateniese si prova facilmente: basta confrontare una pagine di Demostene o Isocrate con qualche passo di Omero o di Erodoto, per notare come in questi ultimi autori la subordinazione abbia uno spazio in genere più modesto. Anche in Roma il periodo complesso si affermò in modo definitivo quando ferveva in modo più vivace la lotta politica: sembra quasi che vi sia un’interconnessione tra il periodare ampio e l’ordinamento democratico: dovrebbero ricordarsene i politici che vorrebbero ridurre lo spazio della cultura classica nelle scuole col pretesto che essa non corrisponde più ai bisogni dei tempi!
Roma perfezionò il modello appreso dai greci con un’aggiunta di grande importanza: la possibilità di determinare in modo preciso le coordinate cronologiche delle azioni, sfruttando l’esistenza nel proprio sistema verbale di una categoria (il tempo) che nel sistema verbale greco ha una presenza assai più limitata, essendo il sistema medesimo orientato piuttosto all’espressione dell’aspetto. Un periodo latino descrive con assoluta precisione sia la collocazione dell’azione fondamentale nel tempo (cronologia assoluta: presente passato futuro) sia il situarsi rispetto a questa delle azioni accessorie (cronologia relativa: contemporaneamente prima dopo). Accanto a ciò, portando a compimento le potenzialità insite nei modi, il latino è in grado di asserire con la massima precisione il grado di obiettività con cui ogni affermazione viene presentata, distinguendo ciò che è certo da ciò che è solo possibile o eventuale o frutto di un’affermazione altrui (c’è differenza tra miror quod venisti e miror quod veneris). Da una semplice frase come la seguente: cum nuntiavissent te Romam venturum esse, omnia paravi, sappiamo che la venuta dell’interlocutore è successiva all’annunzio che ne è stato dato, e che questo è a sua volta anteriore rispetto al paravi che costituisce il nucleo centrale della frase.
La fase cruciale del processo si pone nel periodo che intercorre tra Plauto e Terenzio: è in quest’epoca, ad esempio, che si diffonde l’uso del cum narrativo, una costruzione ignota a Plauto e molto amata dagli autori dell’ultima età repubblicana, tanto da divenire uno dei cardini del periodare latino. L’ultimo esempio in prosa di un’interrogativa diretta con l’indicativo si ha nella Rhetorica ad Herennium: il che significa che solamente in questo momento diventa definitiva la specializzazione dei modi: una struttura del tipo ignoro quid facis rappresenta una contraddizione in termini rispetto alla norma che esige l’uso del congiuntivo per tutto ciò che non è riferito come dato di fatto.
L’indicazione obbligatoria delle coordinate cronologiche è diventata oggi patrimonio comune nella sintassi europea ed è sentita come irrinunciabile. Questo spiega la genesi nei verbi delle lingue germaniche di forme come ingl. I had seen, ted. ich hatte gesehen, sved. jag hade sett ‘io avevo visto’: nella fase più antica di queste lingue esisteva solo una forma semplice, il preterito, che indicava genericamente l’azione passata. Le grammatiche storiche dell’inglese documentano quanto sia recente l’affermarsi dei tipi I have written e I had written: nella fase più antica della lingua bastava il tipo I wrote per esprimere il senso di ‘scrissi, scrivevo, ho scritto, avevo scritto’. Più in generale, i testi più antichi scritti in lingue germaniche mostrano quanto sia grande il tributo che queste lingue devono al modello latino. Il testo più antico, rappresentato dalla traduzione gotica della Bibbia (IV secolo), è scarsamente significativo, perché, trattandosi di traduzione da un originale greco, la necessità di adeguarsi alla sintassi del modello ha portato il traduttore Wulfila a mettere insieme periodi di una certa consistenza. Se si osserva la sintassi dei più antichi poemi eroico-epici nordici (le Saghe e la poesia degli scaldi, IX-X secolo), gli unici testi ancora immuni da significative influenze dei modelli classici, si nota invece come la narrazione proceda con periodi brevi, non collegati fra di loro, e la subordinazione sia pressoché assente. Nelle tradizioni indeuropee dell’Asia troviamo differenze ancora più grandi. Chiunque abbia una conoscenza anche rudimentale del sanscrito sa come in questa lingua per l’espressione di concetti complessi ci si serva di strategie completamente diverse. Mentre sono poche le subordinate esplicite, si fa un uso abbondante di assolutivi (forme verbali invariabili che per la loro natura non sono in grado di esprimere relazioni di tempo), e ha assunto uno spazio notevole (in alcuni testi addirittura impressionante) la composizione nominale: nei composti, talora di numerosi membri, vengono concentrate, ed organizzate gerarchicamente, espressioni concettuali articolate. Siamo dunque di fronte a modi diversi di comunicare: quanto la frase classica tende a precisare in modo incontrovertibile i rapporti tra i vari elementi del pensiero, altrettanto nella frase sanscrita i rapporti risultano vaghi e imprecisati, e tocca all’interlocutore determinare e sistemare i nessi che collegano le idee.
Nuova Secondaria
Con l’accentuarsi dell’influsso greco, come si è già detto in un precedente intervento, si fa più forte la propensione al periodare complesso. Cicerone teorizza in modo definitivo questo modo di scrivere: si rilegga la parte finale dell’Orator. Il periodo è un’unità perfetta, in cui si raggruppano unità più piccole in sé concluse e disposte simmetricamente: anche nelle unità più piccole si dovrà poi disporre i singoli elementi nella maniera più appropriata. Il tutto è riassunto all’inizio del paragrafo 149: Conlocabuntur igitur verba … ut forma ipsa concinnitasque verborum conficiat orbem suum, aut ut comprehensio numerose et apte cadat («Le parole saranno disposte in modo tale che il giro stesso della frase e la simmetria delle parole realizzino la propria unità o in modo che il periodo abbia un andamento ritmico e adatto»). Affermatasi saldamente nella scuola, questa propensione può presentarsi in modo più attenuato, ma mai abbandonata, neppure da quegli autori che consapevolmente cercano vie espressive diverse (come Seneca o Apuleio). Anche chi si riallaccia a tradizioni stilistiche differenti da quella ciceroniana (Sallustio, Tacito) non viene meno a questi principi: alla ricerca di un ritmo spezzato, esaltando la variazione a norma stilistica assoluta, Tacito presenta un esempio di prosa che si pone agli antipodi dello stile ciceroniano, ma nessuno potrebbe neppure pensare che i suoi periodi siano sciatti o disadorni, e i nessi tra i vari momenti del pensiero sono sempre chiaramente individuati.
Anche dopo la fine dell’impero romano, quando la lingua è investita da trasformazioni profonde e nessun settore del sistema si sottrae a un lavorìo di trasformazione e risistemazione, e sia la mancanza di un’azione politica e culturale centralizzata sia il decadere delle scuole pongono le premesse per un più rapido dissolversi della lingua nelle varietà romanze, il periodare complesso costituisce comunque il modello di riferimento: di esso si servono gli autori ecclesiastici e gli scrittori che fanno rivivere e adattano ai loro tempi la storiografia romana. Si legga l’inizio della Storia dei Franchi di Gregorio di Tours (VI secolo): Decedente atque immo potius pereunte ab urbibus Gallicanis liberalium cultura litterarum, cum nonnullae res gererentur vel rectae vel improbae, ac feretas gentium desaeviret, regum furor acueretur, eclesiae inpugnarentur ad hereticis, a catholicis tegerentur, ferveret Christi fides in plurimis, tepisceret in nonnullis, ipsae quoque eclesiae vel diterentur a devotis vel nudarentur a perfides, nec repperire possit quisquam peritus dialectica in arte grammaticus, qui haec aut stile prosaico aut metrico depingeret versu («Mentre in tutte le città della Gallia decade o piuttosto va in rovina la cultura letteraria, in un momento in cui si operano imprese valorose o malvagie, e la ferocia delle genti infuria e si acuisce il furore dei re, le chiese vengono espugnate dagli eretici, protette dai cattolici, la fede di Cristo è vigorosa in moltissimi, è tiepida in alcuni, e le stesse chiese o vengono arricchite dai devoti o spogliate dagli infedeli, non si potrebbe trovare alcun grammatico esperto nell’arte dialettica che sappia descrivere in prosa o in poesia questi avvenimenti»). Gregorio scrive nel suo latino, che è un po’ diverso da quello classico che ci è familiare, nella fonetica (feretas per feritas, perfides per perfidis, tepisceret per tepesceret e così via) e nel lessico, impacciato nella consecutio, ma mantiene il ricordo dell’antica tradizione prosastica in questa solenne apertura: il periodo si apre con un ablativo assoluto e prosegue e con una nutrita serie di cum narrativi, e il dosarsi di simmetria e asimmetria, di asindeto e polisindeto, l’uso dei chiasmi e la collocazione delle parole crea alla fine una compagine ricca di fascino.
L’uso di periodi ampi è meno pronunciato nelle opere di carattere tecnico, per la loro indole stilisticamente meno curata e la loro finalità essenzialmente pragmatica. In Petronio troviamo passaggi come il seguente (Sat. 38): Valde sucosi sunt. Vides illum qui in imo imus recumbit: hodie sua octingenta possidet. De nihilo crevit. Modo solebat collo suo ligna portare («Sono pieni di soldi. Vedi quello che sta sdraiato nel punto più basso. Oggi ha i suoi ottocentomila. Si è fatto dal niente. Fino a ieri portava la legna sulla schiena»). Qui però questo modo disarticolato di giustapporre le proposizioni una di seguito all’altra discende dalla decisione dell’autore di imitare il parlato.
Non stupisce che nei più antichi testi romanzi prevalga la paratassi rispetto all’ipotassi. Questo spostamento di prospettiva può in parte essere motivato da ragioni linguistiche, perché la scomparsa della declinazione rende più rigida la collocazione delle parole, e pertanto meno agevole quei richiami da un punto all’altro del periodo che favoriscono l’affermarsi di strutture ampie e complesse. Ma la ragione più profonda sta nel carattere stesso dei testi, che sono o testi di poesie o testi in stretta relazione col parlato: per le opere impegnative si usa comunque il latino. Solamente quando la lingua romanza assume anche il ruolo di lingua di cultura si pone il problema: e a questo punto l’imitazione dello stile latino diventa impegno primario degli autori che decidono di utilizzare il volgare in luogo del latino. Basta leggere una qualsiasi pagina del Convivio dantesco per vedere quanto il modello latino abbia penetrato in profondità il testo romanzo. Gli stessi caratteri si rinvengono poi nel Boccaccio e in sostanza in tutta la tradizione successiva della prosa elevata. L’evoluzione successiva esula dai nostri scopi. Basti constatare come anche la nostra tradizione letteraria abbia ribadito l’efficacia del periodare complesso: ausilio per chi redige il testo, in quanto obbliga alla sintesi e all’astrazione e impone una precisa gerarchizzazione logica, e strumento per l’interlocutore, in quanto riconosce più facilmente il processo mentale che sta alla base del testo.
LA PRONUNCIA DEL LATINO
Nuova Secondaria
Assistiamo da qualche tempo all’imporsi nella prassi scolastica della cosiddetta “pronunzia classica” (o restituta) del latino. Dopo che per generazioni la pronunzia tradizionale è stata l’unica ad avere circolazione nella scuola, la scelta della pronunzia cosiddetta classica, consigliata anche da innovativi orientamenti didattici che in alcune situazioni e in varie zone d’Italia godono di particolare simpatia, ha oggi un seguito abbastanza ampio: inoltre questa sta conoscendo notevole espansione in molte sedi accademiche e in ambito internazionale. Vorremmo qui considerare il problema, valutando i pro e i contro dei due metodi da un punto di vista strettamente didattico.
Prima di esprimere qualunque parere sarà utile riassumere le differenze fondamentali tra la restituta e la pronunzia tradizionale.
La restituta intende riprodurre la pronunzia del latino dell’età cesariana o augustea; va da sé che, considerata la diffusione della lingua in questo periodo, ci saranno state varie differenti pronunzie del latino: come ci dice espressamente Cicerone (p.es. de oratore III 42), il latino di Roma (sermo urbanus) era pronunziato diversamente rispetto al latino del contado (sermo rusticus), ed è ragionevole pensare che nelle varie province dell’impero esistessero pronunzie locali. Nella stessa Roma la lingua veniva realizzata diversamente a seconda dei livelli culturali e dei ceti: esisteva un latino meno elevato (al livello più basso quello che gli antichi chiamano il sermo castrensis: il gergo dei soldati, delle taverne, dei vicoli; poi il latino delle gente comune, il cosiddetto sermo vulgaris) e un latino più elevato (sermo familiaris), quello praticato dalle persone di elevata cultura che parlavano una lingua corretta, prossima alla lingua scritta e alla varietà letteraria. La restituta assume come punto di riferimento la varietà del sermo familiaris, quella che alcuni linguisti moderni chiamano “lingua dell’uso” (o, con termine tecnico tedesco, Umgangssprache). Posto che non abbiamo (ovviamente!) registrazioni sonore dell’epoca, quali sono le fonti su cui ci basiamo per ricostruire la pronunzia di molti secoli fa? Essenzialmente: le testimonianze dei grammatici antichi e dei testi letterari (che non di rado accennano anche a problemi linguistici), le traslitterazioni di parole latine in altre lingue, e infine le iscrizioni, nei casi in cui le abitudini grafiche (e soprattutto gli errori di scrittura) riflettono cambiamenti che ci dànno modo di seguire l’evoluzione della lingua e della pronunzia. Per sommi capi, le differenze principali tra le due pronunzie sono le seguenti.
I dittonghi ae e oe (da più antichi ai e oi ancora attestati in epigrafi arcaiche) sono pronunziati come scritti, àe òe. Nella pronunzia rustica erano divenuti e (precisamente e lunga con pronunzia aperta) forse già nel I sec. a.C. Quindi si dirà làetus, fòedus (ma attenzione, una pronunzia con dittongo discendente laètus foèdus sarebbe da considerare anacronistica, perché una realizzazione del genere non è mai esistita!).
V è pronunziato u: quindi veni, vidi, vivo sono resi all’incirca ueni, uidi, uiuo. La spirantizzazione che porta alla pronunzia v comincia nel I sec. d.C. e in alcune aree interferisce col contemporaneo processo di spirantizzazione che anche b subisce, come mostrano varie confusioni grafiche (ancora oggi abbiamo in spagnolo boda ‘matrimonio’ da lat. vota).
Le consonanti c e g davanti a vocale palatale (e, i) mantengono la pronunzia velare: non c’è distinzione tra casus e cinis, tra genus e gallus. Questo spiega perché dal latino cellarium ‘cantina’ si abbia in tedesco Keller e da Caesar si abbia in greco Kaîsar, in tedesco Kaiser. La pronunzia palatale si affermò nell’epoca imperiale, con esiti diversi nelle varie aree e poi nelle lingue romanze: in parte del sardo il passaggio non avvenne del tutto e si continua a dire kentu, kerbu, iskire dal lat. centum, cervus, scire.Anche gn non aveva l’odierna pronunzia di n palatale e si usa renderlo come g + n: in realtà g davanti n aveva una pronunzia di n velare (ŋ) (simile cioè a quella di it. ancora, angolo): quindi agnus pronunziato aŋnus, ma distinto da annus (in sardo abbiamo mannu, linna da magnus, ligna); gnatus pronunziato ŋatus e infine natus.
T seguita da i + vocale è pronunziata t: pertanto iustitia e natio così come sono scritte; le prime indicazioni di ts risalgono al II sec. d.C.
S intervocalico ha sempre pronunzia sorda: quindi rosa, misi con la –s– di presentire, non con la s di presentare.
Y, che si incontra solamente in parole di origine greca, nella lingua corretta è pronunziato ü (u di francese mur, lune), con la pronunzia cioè del greco letterario. Ripreso nei prestiti più antichi in modo approssimativo come u (p.es. purpura da gr. porphýra), y ha poi in latino la stessa sorte del corrispondente fonema del greco e diviene in genere i.
Anche l’evoluzione delle consonanti aspirate ph, th, ch, tutte di origine greca, è stata influenzata dalle parallele vicende delle loro omologhe greche. Nel latino arcaico ci si accontenta di trascrivere questi suoni senza aspirazione (Plauto scrive Ampitruo, e sucopanta, non sycophanta, come si ebbe successivamente): nel latino dell’età cesariana (e dunque nella pronunzia restituta) l’imitazione dei modelli greci iimpone per questi fonemi una realizzazione con una leggera aspirazione dopo l’occlusiva (philosophia, Corinthus). In séguito prevale una pronunzia fricativa, che in latino riguarda solamente ph, che viene a confondersi con f (quindi filosofia). Non mancano però incertezze e contraddizioni.
Altre caratteristiche ben documentate nell’epoca ciceroniana (per esempio la caduta di –n– nel nesso –ns-: mensis pronunziato mesis, continuato nell’italiano mese, o mensa pronunziato mesa, che si riflette nello spagnolo mesa ‘tavola’) non sono prese in considerazione, in quanto respinte dalla tradizione scolastica antica, spesso orientata dalla grafia storica delle parole (quindi mensis, mensa e così via).
Nuova Secondaria
Se l’intendimento della pronunzia classica è quello di riprodurre, nei limiti del possibile, la pronunzia corrente nell’età cesariana, si dovrebbe tenere conto anche di quelli che i linguisti sono soliti chiamare “tratti prosodici”. Senza entrare in particolari troppo tecnici, ci limitiamo a richiamare per il latino il tratto della quantità e l’accento.
In latino le vocali possono essere pronunziate con una maggiore o minore durata: la diversa lunghezza della vocale costituisce un tratto distintivo per cui venit ‘viene’ è diverso da venit ‘venne’, e populus ‘pioppo’ è diverso da populus ‘popolo’; il parlante percepisce la diversa quantità vocalica, e la sua sensibilità è tale che, come ci racconta Cicerone, l’attore che sulla scena sbaglia nel pronunziare una lunga o una breve viene fischiato dal pubblico. Con un processo attuatosi in maniera diversa e in epoca diversa nelle varie province dell’impero, ma sicuramente iniziato abbastanza presto, la distinzione quantitativa è stata abbandonata, sostituita da una diversa organizzazione del sistema vocalico basato sull’apertura e sul timbro delle vocali: anziché opporre la lunga alla breve il parlante oppone la vocale chiusa alla vocale aperta, come si può apprezzare anche dalla situazione italiana: lat. novem dà in italiano nove (con o aperta), mentre solem dà sole (con o chiusa). Notiamo per inciso che quanto detto finora riguarda la quantità delle vocale, non delle sillabe: ai fini metrici a determinare i piedi e i versi è la quantità delle sillabe, che è in relazione con la quantità vocalica, ma non coincide con questa: una sillaba con vocale breve e terminante per consonante può essere considerata lunga se la sillaba successiva inizia per consonante: in arma virumque cano solamente l’ultima vocale (e di conseguenza la sillaba in cui essa si trova) è lunga, ma dal punto di vista metrico vanno considerate lunghe anche le sillabe ar di arma e rum di virumque.
Per quanto riguarda l’accento la situazione è molto più complessa. Noi sappiamo dove si collocava l’accento latino in epoca classica: le regole cosiddette della terzultima e del trisillabismo ci consentono di stabilire che in divitem l’accento è sulla prima sillaba e in debere sulla seconda. Sappiamo anche che questa regola non ha validità assoluta in ogni epoca del latino. Nell’età più antica, anteriormente alla nascita della letteratura, l’accento cadeva sistematicamente e invariabilmente sulla prima sillaba della parola. Questo accento aveva natura espiratoria, vale a dire che la sillaba accentata era distinta dalla maggiore energia articolatoria con cui la sillaba tonica veniva realizzata, e questo sforzo determinava anche un’articolazione meno vigorosa (e spesso meno chiara) delle altre sillabe. È in grazia di questo accento molto forte che le vocali brevi in interno di parola cambiano timbro, spesso diventando i (confacio, conteneo divengono conficio, contineo), o cadono del tutto (audacter da *audaciter, reppuli da *repepuli, pono da *posino, ecc.). All’epoca di Plauto l’accento poteva ancora retrocedere fino alla quartultima sillaba, e si poteva pronunziare fàcilius, séquimini. Nell’età tarda abbiamo di nuovo un accento espiratorio: la sua collocazione corrisponde spesso, ma non sempre a quella del latino classico: p.es. si pronunzia revídet, pariétem, nonostante che le due vocali siano brevi (da qui in italiano rivede, parete), sínapi (> it. senape), benché la a sia lunga. Abbiamo ancora una certa debolezza del vocalismo interno che tende a cadere (meno spesso in italiano e rumeno, quasi sempre nelle lingue romanze occidentali), cosicché p.es. genuculum, diminutivo di genu, diviene genuclu e poi ginocchio, capulum diviene caplum e poi cappio, vetulus diviene vetlus, poi veclus e infine vecchio, e via dicendo. Abbiamo dunque discrete certezze per quanto riguarda il latino anteriormente all’epoca classica e posteriormente a questa. Ma all’epoca di Cicerone qual era veramente la natura dell’accento latino? A questa domanda sono state date due diverse risposte: secondo gli studiosi della scuola tedesca l’accento latino classico era espiratorio, come quello dell’epoca precedente e quello dell’epoca seguente; secondo gli studiosi della scuola francese (che difendono questa tesi con vigore) l’accento classico latino era di natura musicale. A questa conclusione essi arrivano esaminando le poche testimonianze che troviamo in Cicerone (orator 173) e Quintiliano (I 5, 29 ss.), i quali sembrano accennare (ma la cosa è tutt’altro che chiara!) a elevazioni e abbassamenti della voce nella pronunzia delle parole e alla presenza di sillabe acute e circonflesse in latino. In realtà queste affermazioni, peraltro confuse, secondo molti studiosi hanno poco o nessun valore: i grammatici latini si sarebbero fatti influenzare dalla tradizione grammaticale greca: poiché il greco aveva all’epoca un’accentazione basata prevalentemente sull’intonazione, con la distinzione di sillabe acute e circonflesse (intonazione ascendente e discendente), i latini avrebbero meccanicamente applicato alla loro lingua i principi dell’accentazione greca (soprattutto in Quintiliano questo fatto appare in modo molto chiaro), finendo per confondersi e per confonderci le idee. La stessa parola accentus (da ad + cantus), col suo riferimento alla melodia, non è altro che la resa letterale in latino del termine greco prosodía, che sottolinea appunto la stretta affinità esistente tra parlato e musica nel continuo elevarsi ed abbassarsi della voce.
Fermo restando che l’approdo a una soluzione del problema è per ora impossibile, un’ipotesi plausibile, sostenuta da alcuni studiosi (anche italiani), è che esistessero diverse modalità di accentazione nella Roma dell’età cesariana. È possibile che nella pronunzia corrente (sermo vulgaris) l’accento fosse espiratorio, mentre negli ambienti culturalmente più elevati, col dilagare della moda greca, si affettava una pronunzia modellata sulle intonazioni del greco. L’unica cosa certa è l’impossibilità di arrivare a una soluzione soddisfacente della questione.
Nuova Secondaria
Delineate così le principali caratteristiche della restituta, si può procedere a un tentativo di giudizio sulla sua utilizzabilità didattica, anche in confronto con la pronunzia tradizionale. Ci sembra che vari aspetti debbano essere messi in rilievo.
1. Innanzitutto una pratica corretta della restituta comporta un impegno tutt’altro che indifferente e approda sempre e comunque a risultati parziali, lontani dagli intendimenti a cui si mira. Pronunziare il latino secondo la restituta significa infatti mettere in rilievo tutte le vocali lunghe e le brevi. In caso contrario, si ha semplicemente una pronunzia italiana con consonanti velari, u consonantiche e poco più, una risciacquatura della pronunzia nazionale che ha scarso significato. Valuti dunque l’insegnante se, nella scarsità di tempo che ha a disposizione, valga la pena impegnarsi alla corretta resa della quantità, alla sottolineatura che la prima i di infelix e insanus è lunga e quella di incertus e intentus è breve. Il risultato a cui si perviene anche dopo questo sforzo defatigante (e a nostro parere superfluo) è comunque sempre approssimativo, perché la realizzazione dei fonemi può essere ricostruita con discreta sicurezza, ma quella dei tratti prosodici no: come abbiamo già visto, non siamo in grado di dire quale tipo di accento avesse il latino dell’età classica.
2. Se si confrontano fra loro pronunzia tradizionale e restituta, si ha da una parte la continuazione di una prassi che si rifà alla tradizione scolastica tardoantica, dall’altra una ricostruzione moderna scientificamente corretta, ma pur sempre astratta e artificiosa. Non si dimentichi che la pronunzia del latino in Italia si pone in modo totalmente diverso rispetto alle altre nazioni europee: la pronunzia italiana è al termine di una storia che affonda le sue radici nel mondo tardoantico (la nostra pronunzia potrebbe corrispondere all’incirca alla pronunzia colta dell’epoca di Boezio, tanto per avere un punto riferimento), mentre quella degli altri paesi europei (Caesar pronunziato Sesàr dai francesi, Zésar dai tedeschi, Sisa dagli inglesi) è priva di senso, perché grosso modo applica ai classici le norme e le consuetudini della pronunzia moderna.
3. Se l’intendimento è quello di avvicinarsi il più possibile, nella lettura dei testi, alla situazione antica, rifiutando di leggere Cicerone e Virgilio in una maniera che avrebbe ripugnato alle loro orecchie, si parte da una posizione di principio corretta, ma non tale da risolvere il problema, perché si finirebbe per leggere Cicerone e Virgilio in una maniera un po’ più vicina a quella da loro usata, ma si cadrebbe di nuovo nell’anacronismo quando si leggessero testi delle epoche precedenti o seguenti. In Tacito, ad esempio, au era letto o, non più au. La parola mulierem era letta mùlierem da Plauto, mulìerem da Cesare, muljèrem nell’età tarda (da cui it. mogliera e spagnolo mujer). Si dovrebbe, a questo punto, leggere ogni autore secondo la pronunzia del suo tempo: ma questo, come ognuno capisce, è inattuabile. Dunque la scelta della restituta non può vantare una sia pure astratta superiorità di rigore metodologico o scientifico: la restituta non può essere considerata la “vera” pronunzia del latino, perché si tratta di una modalità di esecuzione che ha limiti cronologici e sociolinguistici ben definiti e sarebbe un abbaglio pensare di poterla estendere a tutta la Latinità.
4. Infine, c’è un’ultima considerazione che vorremmo sottolineare. Finora abbiamo parlato di pronunzia nazionale italiana: dovremmo, più correttamente, parlare di pronunzia ecclesiastica, perché la nostra pronunzia tradizionale corrisponde alla pronunzia dell’uso ecclesiastico, esplicitamente raccomandata da Pio X (a prezzo di durissime polemiche e contestazioni, soprattutto in Francia) in una lettera pastorale del 1912. Ciò significa che la pronunzia tradizionale ha una diffusione ben superiore ai nostri confini, anzi ha un carattere di universalità, essendo utilizzata non solamente nelle celebrazioni cattoliche finlandesi o neozelandesi, ma anche in tutto quel gigantesco repertorio di opere vocali e artistiche che fanno capo alla tradizione cristiana. Nessuno si sognerebbe di cantare il Magnificat di Bach con la pronunzia restituta!
In sostanza. Ci sembra giusto e corretto che gli alunni sappiano che il nostro modo di pronunziare il latino non corrisponde a quello usato da Cesare ed è giusto che l’insegnante faccia presente le principali differenze tra le due modalità, magari in qualche caso dando un saggio di lettura dei testi secondo pronunzie diverse. Ci sembra giusto ribadire la sostanziale impossibilità di riprodurre in modo adeguato la pronunzia che si usava nel Foro all’epoca di Cicerone. Abbiamo messo in rilievo il costo, in termini di impegno didattico e di utilizzazione del tempo a disposizione, che avrebbe un tentativo di realizzare la restituta in modo coerente. Abbiamo richiamato le ragioni di carattere storico (e ideale) che fanno propendere per la pronunzia tradizionale. Fermo restando che la scelta finale è affidata alla sensibilità del docente, vorremmo concludere con un’osservazione che a noi sembra comunque prioritaria. Studiare il latino oggi ha tra le sue motivazioni fondamentali quella di una ripresa di coscienza della nostra tradizione culturale e della nostra identità, fondata sull’incontro tra cultura antica e Cristianesimo (come ci è stato ribadito più volte, in questi ultimi mesi, anche dalla voce autorevole di Benedetto XVI). Si tratta quindi di motivazioni saldamente e profondamente culturali. In questa prospettiva la conoscenza della lingua è strumento indispensabile per perseguire questa finalità in modo non superficiale e non dilettantesco. Va da sé che si deve trovare il giusto equilibrio tra acquisizione delle strutture linguistiche e riflessione sulla cultura e sulla civiltà. Non ci pare (ma questa è una nostra convinzione personale) che una sproporzionata insistenza sugli aspetti esteriori aiuti in questa direzione né il docente né il discente.

